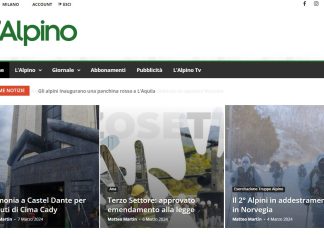Sessant’anni fa la distruzione del monastero fondato da San Benedetto nel 529. Un bombardamento inutile, voluto dai comandanti neozelandesi e inglesi. Il saccheggio di Cassino operato dal contingente marocchino.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il terreno aspro, sassoso e dirupato delle pendici era stato fortificato con postazioni di mortai, caverne artificiali, nidi di mitragliatrici, campi minati, casematte, filo spinato e osservatori. Ai piedi del colle anche l’abitato di Cassino era compreso nel sistema difensivo: i ponti erano stati demoliti e le vie di comunicazione rese impercorribili ai carri armati. Giocarono un ruolo determinante le condizioni meteorologiche: l’inverno 43/44 si rivelò il peggiore del conflitto e un fango viscido si rese padrone assoluto delle strade: la notte del 4 febbraio la neve imbiancò i tetti dell’abbazia. Nonostante le quote modeste, le alture presentavano le caratteristiche dell’alta montagna: i difensori si erano ben presto resi conto che, scomparsa l’immagine solare e marina del meridione d’Italia, avrebbero dovuto operare in uno scenario da prima guerra mondiale. L’alto comando tedesco fu costretto a richiamare dalla Russia una divisione alpina, composta per la maggior parte di montanari austriaci, che difettavano però di esperienza combattiva.
Dirà uno di loro: ‘Sono stato a Stalingrado e non avrei mai immaginato di trovare qualcosa di peggio’ ; altri chiesero di essere rimandati in Russia. Le prestazioni ridotte dei mezzi a motore resero indispensabile la presenza delle salmerie: si dovette provvedere con urgenza all’addestramento dei conducenti. ‘Furono gli stessi muli’ ricorderà il generale Senger, comandante del Corpo Corazzato, ad addestrare gli uomini . Il rapporto di forza, a favore degli alleati, era di 3 a 1 per gli uomini e l0 a 1 per la potenza di fuoco: anche inglesi e americani, bloccati dal fango, dovettero sguinzagliarsi per ogni dove a rastrellare muli e conducenti. Non addestrati al defilamento, erano estremamente vulnerabili al tiro nemico ma, senza di loro, quella guerra non si sarebbe potuta combattere. I soldati del più potente esercito del mondo dovettero convincersi che, in molti casi, un mulo era più utile di dieci carri armati. Nell’interno del monastero i monaci conducevano una vita difficile, ospitando sfollati che trascorrevano la maggior parte del tempo nei rifugi e riducevano paurosamente le scorte alimentari.
Il Vaticano aveva chiesto e ottenuto dai tedeschi che il monastero non fosse fortificato e il maresciallo Kesserling, comandante supremo in Italia, aveva acconsentito, non ritenendolo necessario: non difettavano sulle alture osservatori naturali e aree di tiro in grado di controllare e intervenire su ogni movimento degli avversari. All’ingresso furono poste sentinelle per impedire l’accesso ai militari: per un raggio di trecento metri la zona fu circoscritta da una linea di demarcazione. Inoltre, su richiesta del superiore, l’ottantenne abate Diamare, una colonna di autocarri provvide al trasporto in Vaticano del tesoro del convento, della preziosa biblioteca e delle opere d’arte (alcuni quadri presero però una via diversa, destinati a regalo di compleanno per il feldmaresciallo Goering). Le truppe alleate erano agli ordini del generale americano Mark Clark, comandante della V Armata (due Corpi d’armata statunitensi, uno britannico, uno francese, uno indianoneozelandese), che faceva parte del Corpo di Spedizione in Italia comandato dal maresciallo inglese Harold Alexander.
Nei primi giorni di febbraio gli americani si erano spinti a meno di un chilometro dall’abbazia, ma erano stati bloccati dal fuoco dei difensori, che si erano premurati di rinviare al mittente un piccione viaggiatore catturato, accompagnandolo con un messaggio: ‘Rieccovi il vostro piccione, abbiamo abbastanza da mangiare’. Si era intanto diffusa la convinzione che i tedeschi avessero trasformato il monastero in fortezza: il primo a lanciare l’idea della distruzione fu l’impetuoso generale neozelandese Freyberg, protestante (Clark lo definiva ‘un toro in un negozio di porcellane’), che riuscì a tirare dalla sua Alexander sostenendo che: ‘Mattoni e intonaco, per quanto venerandi, non hanno peso di fronte a una vita umana’. Gli fece eco la stampa inglese: ‘Un vantaggio militare in mano è meglio di due affreschi di Michelangelo alle pareti’. Clark fu costretto a cedere, pur dichiarandola una soluzione stupida e sbagliata, non essendo assolutamente provata la presenza tedesca nell’interno dell’edificio, che avrebbe invece aumentato fortemente il suo valore difensivo.
La mattina del 15 febbraio 1944, nella chiesa dei monastero, l’abate Diamare stava celebrando la messa alla presenza di cinque monaci e duecento sfollati, tutti certi di trovarsi in un luogo sicuro, quale era sempre stato. Erano le 9,30 quando, dopo un lancio di volantini di avvertimento, 147 fortezze volanti, decollate da Foggia e da Decimomannu, sganciarono sull’abbazia 350 tonnellate di bombe, seguite subito dopo da bombardieri medi, per complessive 600 tonnellate. Tutti si erano rifugiati nella cripta di San Benedetto, rimasta miracolosamente immune da crolli. La grande costruzione fu ridotta a un ammasso di macerie. Nessuna vittima fra i tedeschi, totalmente assenti nell’interno dell’abbazia. Liberati da ogni vincolo, si sentirono autorizzati a occupare le rovine, che i paracadutisti trasformarono in un caposaldo inespugnabile, dove resisteranno per tre mesi e dal quale si ritireranno volontariamente per non essere aggirati. I risultati del bombardamento furono tutti a loro favore. Un mese dopo una seconda incursione aerea distrugge la città di Cassino, che assume un aspetto spettrale.
Alcuni reparti indiani e nepalesi si spingono fino a duecento metri dall’abbazia, ma vi rimangono inchiodati per otto giorni. L’l1 maggio milleseicento cannoni investono i difensori con un inferno di fuoco. A farli sloggiare sono i marocchini del contingente francese, addestrati sulle montagne africane, combattenti nati, famigerati per la loro ferocia: non facevano prigionieri e riportavano come trofei le teste dei nemici uccisi. Il loro generale Juin, soprannominatosi Annibale, non aveva perdonato all’Italia l’aggressione del 1940 e aveva concesso alle sue truppe libertà di preda e di saccheggio, esercitata soprattutto sull’inerme popolazione di Cassino, sottoposta a violenze d’ogni genere. Quando i paracadutisti tedeschi si ritirano la strada per Roma è aperta.
Chiederà di entrarci per primo ‘Annibale’ Juin ma, come al suo grande omonimo, anche lui proveniente da sud, non gli sarà concesso. Toccherà invece al generale Clark, che capita in jeep a piazza San Pietro, dove si fa indicare da un sacerdote la strada per il Campidoglio. Parcheggia ai piedi della scalinata e sale a bussare alla porta. ‘In quel momento dirà in seguito non mi sentivo affatto il conquistatore .