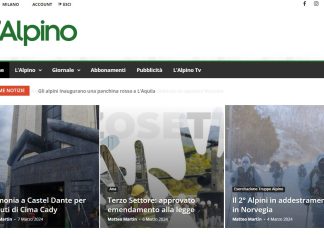Sono trascorsi vent’anni dall’inizio dei lavori per la costruzione dell’asilo “Sorriso” a Rossosch, a ricordo del sacrificio del Corpo d’Armata alpino mandato allo sbaraglio con l’Armir nella sciagurata invasione della Russia, a fianco della Wehrmacht. Follia di dittatori. Gli alpini, si sa, si comportarono qual sono: obbedienti e fedeli al dovere, capaci di eroismi quotidiani ma incapaci di odiare, generosi sempre. Quell’asilo costruito sui luoghi della battaglia è la dimostrazione del loro desiderio di pace e di fraternità.
Con questi sentimenti, a fine aprile scorso, si sono riuniti a Fiume Veneto per la quarta volta molti dei 700 volontari che lo costruirono: un appuntamento con la partecipazione del presidente nazionale Perona, del vice presidente vicario Favero, del presidente della sezione di Pordenone Giovanni Gasparet e la presenza significativa del sindaco di Rossosch Juri Mishankov e del presidente del consiglio comunale della cittadina Eduard Markov. “Ciò che avete fatto sarà di esempio all’Italia di oggi e di domani, perché date col cuore. Grazie di aver piantato un fiore.
Siate orgogliosi, sapendo che l’Italia vi ama ed ha bisogno di voi”, ha detto all’omelia mons. Angelo Santarossa, generale di brigata, che ha ricordato di aver partecipato all’inaugurazione dell’asilo il 19 settembre 1993, in qualità di cappellano militare capo del IV Corpo d’armata, al fianco dell’ordinario militare mons. Giovanni Marra. Nonostante fosse ancora convalescente da una grave malattia, mons. Santarossa non ha voluto mancare a questo quarto incontro con i volontari alpini di Rossosch, che ha ringraziato per il loro impegno.
Gli interventi ufficiali sono stati aperti dal presidente sezionale Giovanni Gasparet, che si è detto onorato di ospitare questo 4° raduno. Gasparet ha messo l’accento sul significato dell’Asilo Sorriso: “un monumento vivente a perenne ricordo del sacrificio dei giovani alpini di allora”. Con gratitudine il sindaco di Rossosch Juri Mishankov ha portato il saluto della propria città, esprimendo apprezzamento per l’invito al raduno, che ha promesso di ricambiare.
Un saluto particolare agli amici della delegazione russa è stato rivolto dal presidente della Commissione Rossosch e vice presidente nazionale vicario Sebastiano Favero, che ha poi ingraziato per la partecipazione il presidente Perona e i volontari, gli alpini di Pordenone, il Gruppo e la comunità di Fiume Veneto per l’accoglienza. Favero ha quindi ripercorso la tempistica del progetto, dal primo viaggio a Rossosch nell’ottobre 1991 assieme al reduce di Russia Ferruccio Panazza, ideatore del progetto e ricordato l’emozione quando il vice presidente nazionale Bortolo Busnardo – recentemente scomparso – gli comunicò che il CDN aveva approvato l’iniziativa che era stata denominata “Operazione Sorriso”.
Quindi, i trenta giorni per presentare il progetto, poi il susseguirsi dei lavori, assicurati da turni di 30 alpini ogni 15 giorni, coinvolgendo oltre 700 volontari da marzo/aprile 1992 fino a settembre 1993. Favero ha rivolto un pensiero riconoscente ai 200 volontari andati avanti in questi vent’anni e al precedente sindaco di Rossosch, Igor Ivanov, scomparso nel 2009, che fu di grande aiuto nella realizzazione dell’asilo. “Parlare di Rossosch suscita un giusto orgoglio”, ha quindi esordito il presidente Perona, che ha ricordato quanto sia stato difficile, allora, prendere contatto con le autorità russe per proporre un progetto che attraverso i bambini parlasse di pace.
Rivolgendosi poi alla delegazione ospite: “Siamo riconoscenti alle autorità russe e alla città di Rossosch che accettarono senza esitazione la nostra proposta”. Commosso, Perona ha parlato dell’incontro avuto durante una sua visita a Nikolajewka con una contadina che seminava patate in un campo. La donna raccontò che sua madre era solita prenderla per mano e portarla a deporre un fiore su una fossa comune: “Qui dobbiamo farci il segno della croce, mi diceva, qui dobbiamo pregare perché questi uomini sono morti senza il conforto di una preghiera, senza il conforto di una lacrima”. Perona ha concluso: “Ho lasciato Nikolajewka con ben presente una cosa: solo attraverso questi sentimenti di grandissima umanità gli uomini si possono confrontare.
Il prossimo anno ci sarà il 20° anniversario e l’asilo è in perfette condizioni. Ma ciò che è straordinario è che 20 anni dopo non abbiamo perduto la memoria di tutti coloro che per costruire questo asilo hanno dato loro stessi”. Conclusa la parte celebrativa, è stata consegnata la Croce di Cavaliere Ufficiale conferita al vice presidente sezionale Aldo Del Bianco per l’impegno straordinario profuso nell’ambito dell’attività dell’ANA in questi anni. Poi la consegna di doni ai tre rappresentanti russi e infine, da parte del prof. Morozov, dei piastrini di quattro Caduti alpini ai rispettivi famigliari rintracciati con grande impegno da Giovanni Francescutti. Infine, tra la commozione generale, Mariella Zerboni ha letto il diario dettatole dal padre Natale, che evidenzia come, pur nella tragedia della guerra, fosse rimasto ancora spazio per la solidarietà e l’umanità.
Daniele Pellissetti
Quando la solidarietà diventa un atto di coraggio
Mi chiamo Natale, sono nato nel 1914 e per 96 mesi della mia giovinezza ho fatto esercitazioni militari e poi ho combattuto sul Fronte Occidentale, in Albania e in Russia; richiamato nella Guardia Confinaria nel 1944, sono stato per un anno informatore dei partigiani. Molti sono i ricordi che nella mia mente si ricollegano alla solidarietà ed al coraggio, ma ce ne sono alcuni che hanno il sopravvento sugli altri e ogni anno, a Natale, mi travolgono con la stessa dolorosa intensità. Il 25 dicembre, quando mi ritrovo intorno alla tavola imbandita, attorniato dalla mia famiglia, io non posso fare a meno di tornare col cuore a quel lontano e gelido inverno del 1943 trascorso nella steppa russa insieme ai miei compagni del battaglione Morbegno.
Per mesi avevamo costruito trincee sulla riva del Don, quando il 17 gennaio ’43 ricevemmo l’ordine di ritirarci perché accerchiati dai Russi! Marciavamo tutto il giorno e la sera ci ammassavamo in qualche “isba” per non congelare. Il 23 gennaio fummo attaccati dai carri armati nemici a Podgornoje e fummo decimati. Dopo la battaglia mi attardai a cercare disperatamente il mio tenente e mi ritrovai solo, sperduto in quella distesa immensa di neve, a 45° sotto zero. Era l’imbrunire, m’incamminai in quella che mi pareva la direzione giusta e la mia disperata solitudine si ridimensionò un poco quando m’imbattei in un alpino dell’Edolo, anche lui sperduto. Il cielo volle che dopo un po’ raggiungessimo un drappello di alleati tedeschi che però ci volevano brutalmente mandare via; in coda a loro, un po’ in disparte c’era un soldato austriaco che ci disse in italiano di aver prestato servizio al Brennero e c’invitò a seguirlo in silenzio.
Ci rincuorammo e più tardi fummo mandati dai tedeschi a cercare riparo in un’isba diversa da quella in cui si erano rifugiati loro. Non trovammo posto altrove, tutte le case erano stipate di uomini che in piedi l’uno accanto all’altro cercavano di passare la notte senza congelare. Tornammo quindi all’isba dove c’erano i nostri “alleati” che malamente ci permisero di entrare, ci diedero delle patate bollite e ci ordinarono di stare a turno di guardia alla porta.
Quando tutti sembrarono dormire, la padrona di casa, una vecchietta così simile alle nostre nonne, si avvicinò in punta di piedi e ci diede un piumino per coprirci. Si fece l’alba e lontano si sentiva il rumore delle mitraglie russe; nella furia di caricare le loro cose sulla slitta i tedeschi lasciarono per terra nella neve un sacco di zucchero e uno di caffè; io e il mio amico ce ne riempimmo le tasche e poi di corsa tornammo a dare quanto rimasto alla vecchietta: lei s’inginocchiò e più volte alzò la mano a benedirci.
Fu un altro giorno di cammino faticoso, i Tedeschi mandavano noi in avanscoperta e la sera, di nuovo, c’imposero di arrangiarci a trovare qualcosa da mangiare e un riparo. Stremati, pieni di freddo e affamati entrammo in un’isba dove c’era una mamma con i suoi bambini già addormentati. Chiedemmo in russo del pane, la donna c’indicò i bambini e rispose che non aveva cibo. Io alzai gli occhi e sopra la madia scorsi un pane tondo. Lo presi – la donna si mise le mani nei capelli – con la baionetta lo tagliai a metà – la donna ci guardava terrorizzata – ne divisi un mezzo col mio compagno e l’altro mezzo lo ritornai a quella mamma. Lei deve aver capito la nostra fame e la nostra disperazione, nei suoi occhi la compassione prese il posto della paura, si avvicinò alla stufa che c’era nel mezzo della stanza, ne trasse una brocca di latte caldo e ne versò una tazza per ciascuno. La mattina del 26 gennaio raggiungemmo la spianata di Nikolajewka, quello che successe quel giorno è negli annali della storia.
Dopo la carneficina, la colonna dei sopravvissuti iniziò la ritirata verso la Polonia. Il lento procedere era sostenuto dalla speranza di poter essere caricati su un treno, ma questa possibilità sembrava allontanarsi sempre più come in un incubo senza fine. Verso la metà di febbraio io non avevo più forze e ormai mi trascinavo in coda a quella colonna di disperati; ero rassegnato a cadere presto nella neve e morire come avevo visto fare a molti dei miei compagni. Si avvicinò a me un artigliere di montagna e mi disse: “cusa ghet alpino che t’en vee pu?” (che cos’hai alpino che non cammini più?) e io risposi: “go negut, ma ghe la foo pu” (non ho niente, ma non ce la faccio più). L’artigliere allora aggiunse: “scià che te meti su un poo sul me mul!” (dai vieni che ti faccio salire un po’ sul mio mulo).
Mi lasciò tutto il giorno sul suo mulo, seppi che era della Valchiavenna, ma non riuscii neppure a chiedergli come si chiamasse e le ore passarono lente e silenziose. A sera raggiungemmo il grosso della colonna e un sottotenente ci divise per compagnia d’appartenenza; io riuscii solo a mormorare “grazie!” a quel compagno generoso e non lo rividi più. Le mie condizioni erano tra quelle più gravi perché poco dopo fui caricato su un treno merci e portato fino a Gomel. A tratti mi avvicinavo all’Italia dove giunsi a metà marzo a bordo di vagoni piombati perché nessuno ci vedesse. Arrivai all’ospedale militare di San Giovanni in Persiceto irriconoscibile, ero pieno di pidocchi e pesavo 42 chili.
Da 60 anni, quando apro gli occhi ogni mattina, recito la preghiera dell’alpino e ogni giorno della mia vita ringrazio quel soldato austriaco che sfidò i suoi superiori per aiutarci, quella vecchietta russa alla quale avevamo mangiato le patate che s’impietosì e ci diede di che coprirci, quella mamma che seppe condividere col nemico il cibo per i suoi bambini, quell’artigliere di montagna che rischiò il suo sfinimento perché io non morissi – non ho mai saputo il suo nome, ma finché avrò respiro lui resterà per me un fratello.
A quasi 90 anni io curo ancora il mio orto, d’inverno intreccio cesti col legno di nocciolo e quando il tempo è buono vado nei boschi a procurare la legna necessaria a scaldare me e mia moglie. Non mi piace molto e non capisco tanto questo mondo dove si spreca così tanto, dove si sfidano le leggi della natura e non si rispettano i ritmi delle stagioni ma “mi urmai so là in funt al camp” (io ormai sono in fondo al campo della vita). I miei figli sanno che quando la terra delle mie montagne mi accoglierà dovrà esserci con me il mio cappello d’alpino che con orgoglio porto da più di 70 anni. A loro, a tutti i miei cari, lascio le mie esperienze di guerra e di vita che tante volte ho raccontato; spero che nei momenti difficili ne sappiano trarre coraggio e spero che sempre ricordino che dai momenti più dolorosi possono nascere i più generosi doni d’amore.