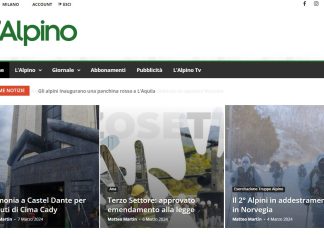Ecco due brani del libro di Caruso:
(20 gennaio Il massacro)
L’incubo sono i carri armati. Sono pochi, ma mancano gli adeguati pezzi controcarro, i 75/38, per affrontarli. Gli alpini vi si avventano come nei libri dell’infanzia hanno letto che facevano i cavalieri contro i draghi. Il capitano Zilioli, comandante della 71a del Gemona, conduce i suoi pochi lazzaroni superstiti all’assalto, il tenente Continenza rende inutilizzabile con le mani il congegno di puntamento di un carro. Si è specializzato nel salire sui carri da dietro spiccando il balzo quasi da fermo. Zilioli lo vuol proporre per una medaglia d’oro: chissà dove si è persa la pratica. Il tenente Crespi e il sottotenente Mutisio portano trentadue genieri del IV battaglione sulla linea del Mondovì. Si battono con la forza della disperazione. Quando la granata di un cannoncino colpisce i cingoli di un bestione e lo ferma il tenente Crespi prepara una molotov, gli si fa sotto, riesce a incendiarlo. Gli italiani si aggrappano a una furia che è figlia dell’impotenza. Non conta vincere, non conta vivere, conta vendicarsi di quei T34, che non si danno neppure la pena di sparare e puntano a schiacciare, conta fargliela vedere a quel nemico che avanza urlando urrà .
È una mischia selvaggia. Non ci sono ordini, disposizioni, manovre da eseguire. Si lotta perché non resta altro da fare. Ci si accanisce intorno a pagliai di nessuna importanza, il fronte ondeggia a secondo di singoli episodi. Gli alpini si raccolgono nei pressi dei cannoni e delle mitragliatrici. Si apre la porta di un’isba e un gruppetto esce di corsa per caricare con bombe e baionette. Lo guida il tenente colonnello Vincenzo Mignone del 1º, alle sue spalle il tenente Assunto Bianco, poi chi ha voglia di giocarsi la vita in una manciata di secondi. I sovietici arretrano, Mignone con il braccio indica di andare avanti, ma è rimasta una schiera esigua. Da dietro, però, arriva il tenente Italo D’Eramo, addetto all’ufficio informazioni del reggimento, un richiamato che a trentasei anni ha scoperto l’orrore della guerra. D’Eramo ha radunato quelli che ha potuto e con la Beretta d’ordinanza in mano è lì dove ritiene che debba essere. È ferito gravemente al torace. Mignone, Bianco e i sopravvissuti di quest’altra carica forse inutile, forse importante per spezzare l’accerchiamento lo riportano indietro. Il che significa fino all’isba da dove il colonnello Manfredi ritto e sprezzante esorta gli artiglieri del Mondovì’ a non sprecare i colpi.
Non li spreca il caporal maggiore Francesco Ferrero, venticinquenne cuneense al comando di una squadra mortai da 81. Veterano del fronte francese e di quello greco albanese, Ferrero è capitato accanto a una batteria da 47/32 priva del suo comandante. Ne ha assunto le funzioni, dirige i colpi dei mortai e dei cannoncini. Ben presto artiglieri e mortaisti sono decimati e circondati. I pezzi vengono messi fuori uso, ne rimane uno solo: dietro di esso Ferrero, l’unico in grado di far funzionare l’arma. All’intimazione della resa risponde con un fuoco rabbioso, ma anche i proiettili a effetto perforante si sono esauriti. Il caporal maggiore spara l’ultimo prima di abbattersi sul cannoncino.
Eroismo dopo eroismo, sacrificio dopo sacrificio le penne nere indietreggiano: alle spalle hanno ormai le isbe occupate dai comandi. L’obiettivo prelibato dei sovietici sono gli artiglieri, i loro pezzi. Dalla cura con cui li cercano pare che abbiano ricevuto un ordine tassativo. D’altronde sanno bene che senza quei pochi cannoni agli italiani resterebbe soltanto il furore. Le batterie sono tartassate, soprattutto quelle del Mondovì. Viene ucciso il tenente Silvio Patrone che ha diretto il tiro dei 47/32 della 101a armi d’accompagnamento.
Viene ucciso il capitano Alessandro Calanchi, comandante della 2a. Viene ucciso il capitano Giuseppe assone comandante della 10a, successore di un altro eroe sconosciuto, il capitano Anton Filippo Donini, che prima di andare a morire era scattato sull’attenti davanti ai cannoni: Addio pezzi della 10a, viva l’Italia . Il comandante dell’11a, il capitano trentunenne Silvio Sibona, genovese di Rivarolo Ligure, sta sulla neve ferito da schegge in più parti del corpo. Assiste impotente al massacro dei suoi. Quando salta anche l’ultimo cannone, si tira su, afferra una bisaccia di bombe a mano e si lancia zoppicando contro un carro armato. È immediatamente fulminato.
Della 11a sopravvivono un pugno di artiglieri e il vice comandante, il tenente Giulio Siragusa, ventiseienne di Gela (Caltanissetta). Siragusa si è battuto come un ossesso, ha sostituito i serventi ai pezzi, ha caricato, ha puntato, ha sparato. Quanti siamo? grida. Quelli che vede risponde il sergente maggiore Michele Filippi, un taciturno piemontese di Cuneo, che da ore fa di tutto. Siragusa raduna intorno a sé lo sparuto gruppetto della batteria. Balzano addosso al nemico, lui e Filippi in testa, gli altri a far da corona. Li attende il paradiso di Cantore.
Rossotto, il tenente colonnello del Conegliano, prova a spedire qualcuno dei suoi al Mondovì. È un’altra ecatombe. Per di più fanteria e carri convergono adesso sul gruppo. La 13a di D’Amico perde un altro pezzo, la 15a del capitano Antonio Monzani è presa d’infilata da tre thank. Il cannone del caporal maggiore Olivio Maronese ne centra uno, ma viene a sua volta centrato. Maronese ha una brutta ferita al fianco, però si regge in piedi, cerca con lo sguardo un pezzo che funzioni, a qualche decina di metri ne adocchia uno del Mondovì abbandonato, vi si trascina. Vi arriva assieme a Monzani. Il capitano fa da puntatore, Maronese da tiratore, un soldato tedesco da servente. Il pezzo del Mondovì torna a funzionare, un carro però lo inquadra. E’ un impari duello medievale: il mostro contro l’uomo, una sola chance disponibile con il cingolato che s’avvicina e i tre del cannone che l’aspettano. Da una parte e dall’altra cercano d’indovinare l’istante propizio per fare il botto. Sparano contemporaneamente. Il carro armato è colpito, così come il cannone.
Monzani è ferito, lo sconosciuto granatiere tedesco è deceduto, Maronese ha le gambe a pezzi. Perde sangue copiosamente, ma ai primi soccorritori sussurra di occuparsi del capitano e dei rossi. Il ventiseienne caporal maggiore friulano muore dissanguato in pochi minuti. Guidati dall’aiutante di battaglia Michele Bernardon alcuni artiglieri della 15a spingono un cannone sotto il T34. Sono fuori dalla visuale del puntatore, li protegge il mitragliere De Meio, che sparando all’impazzata impedisce all’equipaggio di affacciarsi dalla torretta. Viene presa la mira, la granata si stampa sui cingoli, quel malefico thank è sistemato. D’Amico urla come un ossesso per tenere compatti i suoi mentre lui sta ritto sulla neve, pensando magari d’essere immortale: la sera prima è venuto giù il tetto in fiamme di un’isba, lo ha sfiorato bruciacchiando la barba. Adesso una pallottola perfora il cappotto, la giubba e neppure gli scalfisce la pelle. Potrà festeggiare con la bottiglia d’acquavite fattagli poco prima recapitare dal colonnello Cimolino. Assieme a lui berranno in pochi. Il Conegliano è falcidiato. Muoiono i tenenti Pagni e Fassa, muore con un mitra in mano il sergente maggiore Luigi Pasianotto. Nel luglio del ’42 era sbarcato a Taranto dopo sette mesi di prigionia in Grecia.
Aveva scritto a Rossotto per dirgli di voler essere reintegrato nel gruppo. Un mese a casa con la moglie e la bambina e poi via verso l’Unione Sovietica. Il sergente Bruno Zanni fa il pieno di cognac e balza su un thank immobilizzato, si fa passare una mitragliatrice e per quattr’ore se ne sta là sopra a costituire da solo una linea di resistenza.
Ultimi a tacere sono i grossi calibri della 73a batteria del Val Po: non hanno più granate. Il tenente colonnello Rossini, comandante del gruppo Mondovì, convoca allora i superstiti: un fuci
le a testa e via in mezzo agli alpini a far numero, a far muro prima che tutto sia compromesso. Non esistono più compagnie, reggimenti, gruppi, specialisti. Si combatte con le armi che si trovano sulla neve, con quella data da un ferito o strappata a un cadavere. L’importante è sparare, l’importante è fermare la fiumana avversaria. Si rincorrono le notizie più funeste: battaglioni maciullati, batterie travolte, alpini annichiliti, incapaci di qualsiasi reazione o capaci del gesto estremo pur di farla finita. Le isbe adibite a comandi, a infermerie, a ricoveri del poco rimasto paiono sul punto di essere espugnate. E dietro la linea delle isbe, stanno le slitte, i quadrupedi: persi loro sarebbe persa l’ultima fioca speranza di raggiungere la salvezza.
Accade il miracolo. Corradi racconta che nella isba dov’è finito, e che casualmente è quella ospitante Ricagno, Battisti, Cimolino, Manfredi, stanno tutti accovacciati: dalle finestre spiano il passaggio dei sovietici, sono rassegnati al peggio. All’improvviso risuona un urlo: Dai che scappano, dai che scappano L’ha lanciato il capitano Franco Magnani, un alpino della Lomellina cresciuto in mezzo alle risaie e alle zanzare. Magnani è stato un gran combattente sulla Kalitva e nei giorni del dolore si è adoperato per mantenere alto il morale, per conservare attraverso la disciplina la compattezza dei reparti. Aveva un cavallo e con quello è andato su e giù lungo il serpentone attento a che non ci fossero cedimenti, crisi di sfiducia. L’hanno visto adoperare il frustino per impedire che lo scoramento sfociasse nel caos.
Non è vero che il nemico stia scappando, però è come se lo fosse. L’urlo di Magnani accende la ribellione al fato, all’imperizia, all’ineluttabilità. Dall’isba di Corradi e dalle altre vicino centinaia di morituri imbacuccati irrompono sulla spianata. Il colonnello Voghera, l’austero responsabile dei servizi logistici, che un attimo prima aveva poggiato la canna del mitra sotto il mento, ora quel mitra lo usa per farsi largo tra i soldati con il colbacco e con la stella rossa. Contemporaneamente risuona il grido di guerra, che tragicamente accompagnerà la settimana di passione della Julia’ e della Cuneense’: Tutti i vivi all’assalto .
Lo pronuncia Rossotto rivolto ai suoi del Conegliano, lo pronuncia Talamo rivolto ai suoi del Tolmezzo: il maggiore è lì in mezzo agli alpini nonostante un congelamento di terzo grado ai piedi. Gli ufficiali hanno la Beretta in mano, è quasi un ornamento, ma nell’orda che si scaglia fuori riconoscendosi nell’Avanti Savoia! dei campi risorgimentali molti hanno anche meno. Furieri e infermieri, scritturali e congelati, feriti e conducenti, medici e telegrafisti hanno afferrato ciò che avevano sotto mano: coltelli da cucina, asce, baionette, fucili usati come mazze essendo finite le munizioni. Si uniscono gli artiglieri della 73a del Val Po, ormai priva di granate. Anche il capitano Rossi grida Avanti Savoia! e tutti gli vanno dietro. Di questa batteria un solo ufficiale farà ritorno in Italia .
(19 novembre 1942)
Sul Don gelato aumenta il passaggio dei disertori. Evitano tedeschi, ungheresi, rumeni, si consegnano soltanto agli italiani. Insistono nel raccontare di notevoli concentramenti di forze, di un attacco su vasta scala in preparazione, del divieto ai soldati di uscire dalle baracche durante il giorno. Insomma, qualcosa è nell’aria, eppure alle 7,30 del 19 novembre la sorpresa è totale. Scatta il piano Uranus, concepito in settembre e reso possibile dal gigantesco sforzo imposto da Stalin all’industria bellica. Lo Stavka (il quartier generale di Mosca) ha concentrato oltre un milione di uomini, circa 1200 carri armati, 17.000 pezzi d’artiglieria, 120 batterie lanciarazzi, 1300 aerei.
La 5a armata corazzata e la 21a armata colpiscono e affondano nella zona di Serafimovich la 3a armata rumena e lo squinternato XLVIII corpo d’armata tedesco del generale Heim. Il caso vuole che il giorno prima Paulus abbia lanciato le formazioni d’assalto per strappare ai russi i rimasugli di Stalingrado. L’ha fatto dopo l’ennesimo messaggio di Hitler del 17 novembre. Usando un tono diverso dal solito, il Fuhrer lo scongiurava di chiudere il conto.
La risposta germanica all’offensiva è contraddittoria. Le misure del feld maresciallo barone von Weichs, comandante del Gruppo armate B, vengono smentite dagli ordini di Hitler, che stenta a capacitarsi della qualità e dell’ampiezza dell’attacco. I carri armati, i soldati, i treni che sbarcano gli allenatissimi soldati siberiani, mongoli, uzbechi a ridosso della prima linea sembrano sbucati dal nulla, contraddicono le ottimistiche relazioni di Gelhen sull’Armata Rotta.
La Wermacht perde giorni preziosi e perde anche parte della 4a armata corazzata
allorché le affida il compito di ristabilire i collegamenti con la 6a. La trappola russa si è chiusa su Stalingrado. Dentro ci sono anche un pugno di italiani, dei quali è rimasta scarsissima memoria. Si tratta di due gruppi di autieri in servizio con i rifornimenti germanici. Quello del 127º è comandato dal sottotenente cremonese Walter Poli, quello del 248º dal sottotenente Giusberti. Con loro una cinquantina fra soldati e graduati. Ingabbiato in prossimità di Stalingrado c’è pure un oculista, il dottor Cattaneo, con un piccolo seguito di infermieri e assistenti: erano stati assegnati a un’unità chirurgica della Wermacht.
Nel luogo più feroce del pianeta, dove la pietà l’è morta da mesi, il destino di questi italiani si confonde con quello di centinaia di migliaia di tedeschi .