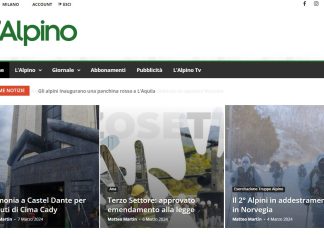Il destino talvolta si presenta beffardo riservando una morte misera a uomini dal vissuto valoroso. Al generale Luigi Reverberi accadde così. Morì a sessantuno anni, il giorno del suo onomastico dopo una vita dal sapore leggendario. Ce ne parla il figlio, ingegner Bruno Reverberi, generoso ad accoglierci nella sua elegante dimora milanese.
“Mio padre l’- ho goduto assai poco” dice con intenso rammarico. “Prima la guerra, poi la prigionia. Non avevamo più notizie io e mia madre, non sapevamo se fosse vivo o morto. Fece ritorno a casa, senza clamore alcuno, un giorno di ottobre del 1945. Io frequentavo l’università, andavo e venivo, come tutti i giovani. Certo non posso scordare il suo dispiacere quando si vide costretto a lasciare l’Esercito nel 1947. Poi nel 1951 a Brescia, la consegna ufficiale della Medaglia d’Oro al Valor Militare. Medaglia che gli era stata conferita nel 1943, ma che non poté ritirare fino ad allora. Visse da alpino, sempre. Prima in armi, dalla Libia alla Russia, poi dedicandosi all’Associazione Nazionale Alpini, stretto ai suoi soldati”. Chiedo: “Ma della guerra non parlava mai? E del suo ultimo sprone, disperato: ‘Tridentina avanti’?”. “Mai nulla. Solo ad un raduno, subito dopo la guerra, ricordando il 26 gennaio 1943 chiuse proprio con quelle parole… ora come allora, Tridentina avanti! Era la prima volta che glielo sentivo dire…”.
In quel lontano 26 gennaio 1943, ‘Tridentina avanti!’ fu il grido che scaldò l’animo degli alpini, ormai sfiniti, disperati. Essi con sforzo coraggioso, allungarono idealmente la loro mano verso tutto ciò che nei loro pensieri si condensava in una sola parola: casa. E furono fuori dalla sacca. Si commuove l’Ingegnere, raccontando di quanto fosse orgoglioso suo padre nel ricordare la partenza da Asti nell’estate del 1941. Dal Piemonte fino al confine orientale, ad ogni stazione uno ad uno, i suoi alpini erano lì in attesa. “Non uno si rifiutò di salire su quel treno, non uno”.
Continua rivelandoci il legame intimo che correva tra suo padre e don Carlo. Con riverente delicatezza, ci mostra la Bibbia che il Beato regalò al suo Generale dopo la guerra. Questa meraviglia, insieme a poche fotografie, è ciò che rimane del General ‘Gasosa’: infaticabile e impavido. Energico, schietto e severo Comandante. Indole allegra la sua che la vita, meglio la guerra, aveva cambiato: i suoi occhi cerchiati di malinconia, impressi sulle fotografie che lo ritraggono a Edolo durante una cerimonia ufficiale il giorno prima di morire, non lasciano dubbio. Migliaia dei suoi ragazzi erano rimasti laggiù: migliaia di passi impressi nella neve si erano interrotti per sempre. Non avrebbero più fatto ritorno.
Questa immagine come la ripetuta melodia di un disco rotto aleggiava nei suoi occhi, ancora e ancora. Era la sua nuova Russia. Una Russia che egli taceva, incapace di raccontare o condividere. Infatti non scrisse mai nulla sulle vicende che lo videro protagonista. Forse semplicemente non ne ebbe il tempo. Solo qualche lettera alla famiglia durante la prigionia. È in queste righe che traspare lo stato d’animo del detenuto, costretto lontano dai propri cari: “So che i miei stanno bene, che mi aspettano e che il mio Bruno si prepara a superare lo scoglio non lieve della licenza liceale. Ho pensato di scrivere qualcosa in questo periodo per portarlo poi a mio figlio il giorno del mio rientro in Italia, ma i pensieri sono così dominati da una nota di malinconia, che ho deciso di rimetterlo a dopo, quando, nella quiete ritrovata del mio spirito e nella serenità della mia casa, dovrò rioccupare il tempo che una volta dedicavo con tanto entusiasmo e tanta passione ai miei soldati’. Continua: “Questi mesi di dolori, dopo la grande tragedia, hanno fortemente inciso sia sul fisico, sia sul morale. Non basta più la primavera per risollevarmi… nel mio cuore persiste il freddo inverno, il gelo e il grigiore, tutto sembra dimenticato… non verrà il giorno nel quale debba scriversi la parola fine a questa inaudita tragedia che insanguina e distrugge il mondo?”.
Questo è l’interrogativo che ha tormentato ogni alpino dopo il ritorno a baita. È la domanda che ha riecheggiato nella mente e nel cuore di ogni reduce. Le parole non bastavano, non bastavano i ricordi e neppure le celebrazioni. Bisognava fare. Bisognava essere alpini nell’animo e ancor di più, nell’azione. E la risposta fu e continua ad essere l’opera di quella meravigliosa cosa che è l’Associazione Nazionale Alpini. Ecco la risposta. In essa è racchiusa l’eredità di Nikolajewka: ancora oggi, in una realtà tanto diversa, così trasformata, le virtù che hanno permesso di superare l’ultima sacca per ritornare a casa, sono quelle che spingono gli alpini a ritrovarsi, in una fredda giornata di gennaio, per ricordare. A guardarli ora, quei cappelli sgualciti e stinti che hanno più di settant’anni ci fanno sentire piccoli. Ma è questione di un attimo. Gli occhi si abbassano e lo sguardo dei reduci ci avvolge di serenità come a dire: siate il meglio di qualunque cosa siate. È l’insegnamento. È l’eredità di Nikolajewka capace di accompagnarci verso una serena consapevolezza del passato. Un’eredità che ci chiede con forza di essere, giorno dopo giorno, uomini migliori.
Mariolina Cattaneo