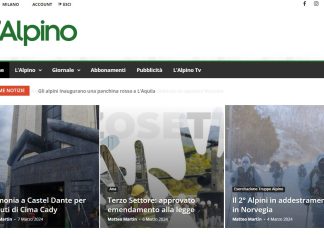Era in prima linea, la notte del 23 dicembre 1942, quando si scatenò la furibonda battaglia del Don. Pochi rammentano quei momenti terribili, ma lui, “Giovan dla Piana”, all’anagrafe Giovanni Ghigonetto della frazione Piana di Calcinere (Valle Po) era al suo posto di combattimento. Da appena cinque giorni aveva compiuto i suoi 21 anni. A tutt’oggi ricorda con sorprendente lucidità ogni minimo particolare: «La situazione di là del Don accennava a qualcosa che sarebbe potuta accadere: non c’era proprio da stare tranquilli, al massimo dell’allerta allora.
Prima di quel momento ancora non si erano avute sparatorie, se si eccettua un’unica raffica partita tre o quattro giorni prima da una mitragliatrice russa nel mentre noi si stava scavando una trincea: i colpi strisciarono sull’erba conficcandosi nel terreno, senza causare feriti. Non abbondavamo per la verità di armamento: potevamo confidare nell’appoggio soltanto di un fucile mitragliatore su bipiede e di due mortai, credo da 45 e da 81. La notte era buia, immersa in un silenzio profondo, tetro, quasi da incubo. Noi, gli occhi ben spalancati e i nervi tesi per la vigilanza assidua, a un tratto balzammo in piedi: era scoppiata una mina. All’improvviso il nero impenetrabile del cielo s’illuminò a giorno.
Davanti a me, quasi a ridosso dei nostri reticolati, un formicolio impressionante di russi che avanzavano. Strano – pensai – una sola mina scoppiata fra le centinaia che avevamo interrato, e al buio, e così in tanti, senza farsi sentire! Avevo con me il ’91 lungo con baionetta da 40 cm inastata, sparai all’impazzata. Il mio vicino, un toscano di cui non ricordo esattamente il nome, forse Vicentini o Piacentini e che vorrei fortemente poter ritrovare, diede mano al suo fucile mitragliatore (Breda 30) ma, dopo aver sparato forse cinque colpi, quello s’inceppò. Il toscano non sapeva più cosa fare. Gli buttai fra le mani il mio ’91 gridandogli: spara, spara! Presi io in consegna il fucile mitragliatore, sapevo come trattarlo, smontai in un attimo i congegni di otturazioneestrazione- espulsione, rimisi in sede la molla e richiusi la testata: funzionava!
Di fianco a me c’era il caporale Stefano Fogliacco di Revello (Valle Po), lo esortai: un caricatore, presto! Il caporale lo infilò nell’arma e io aprii il fuoco. Nonostante il buio fitto sapevo dove dirigere la canna infuocata, il varco utilizzato dai russi per venirci addosso aveva un’estensione limitata con una profondità di circa 150 metri in semipiano e la mia postazione si trovava proprio di fronte. I russi avanzavano con la schiena un po’ incurvata: li vedevamo solo nell’attimo in cui divampavano le luci dei razzi segnalatori. Il bravo caporale sfilava i caricatori da venti colpi, uno dopo l’altro e la mia arma sputò fuoco senza interruzione. Sapevo che se la prima ondata di russi cadeva, ne sarebbe sopravvenuta una seconda, poi un’altra e un’altra ancora, senza fine. Sapevo che stavamo per essere travolti. Fu il momento in cui vidi la morte in faccia.
Continuai a premere il grilletto, non restava altro da fare, nell’attesa dell’urto decisivo. La nostra vera fortuna fu che poco distanti, alle nostre spalle, tre batterie del gruppo Mondovì diressero con precisione una serie di tiri sulla linea nemica che stava per avere il sopravvento su di noi, strappandoci a una morte sicura. Ero stremato, sconvolto da quello scontro micidiale, il mio elmetto portava i segni di tre colpi che lo avevano sfregiato di striscio. Era stato come il dirompere di un uragano. Furono, quelle che seguirono, ore interminabili da apocalisse.
Il mattino del 24, terminata la tempesta, un tenente, non del mio plotone, mi disse di seguirlo. Si arrivava a scorgere poco in lontananza, per via di qualche velo di nebbia. Il terreno di fronte a noi ci apparve come una landa completamente coperta di corpi esanimi, cosparsa qua e là di manifesti che incitavano alla resa e di una gran quantità di materiali, cucine complete prive di viveri. Eravamo coscienti del rischio che stavamo correndo, ma non vi furono reazioni da parte dei russi. Udimmo alcuni lamenti: provenivano da alcuni nostri avversari irrecuperabili, giunti agli ultimi stadi di una straziante agonia. Il tenente pose fine alle sofferenze di undici di loro con un colpo di grazia.
Noi lamentammo sei feriti, uno di loro era mio fratello che fu catturato e lasciò la vita in terra di Russia; ci fu un solo caduto della mia Compagnia, la 23a del battaglione Saluzzo; lo seppellimmo a poca distanza dalle postazioni. In seguito a quella strage non si sparò più. I russi, cosa ancora sorprendente perché non ne udimmo i rumori nonostante avessero dovuto scavare in profondità nella terra gelata, riuscirono nella notte a ricavare a poche decine di metri dalle nostre trincee una grande fossa nella quale deposero più di duecento salme. Raccoglievano mestamente i loro morti, sotto la protezione di una bandiera bianca issata sul posto.
Ero sfinito, mi sentivo crollare. Insieme al caporale il 7 gennaio 1943 fui portato a Rossosch per le prime cure e di lì, visto il mio stato di salute preoccupante, fui trasferito sei giorni dopo all’ospedale di Karkov dove mi sentivo oppresso da un dolore lancinante per un incipiente congelamento agli arti inferiori. Con tutto ciò e nell’enorme sofferenza di quelle ore, credetti di potermi sentire orgoglioso perché, ne sono convinto e lo fu anche il caporale Fogliacco, che se non mi fossi preso la responsabilità di quel fucile mitragliatore, i russi sarebbero senz’altro penetrati per quel varco entro le nostre trincee. Quello sarebbe stato con ogni probabilità l’inizio della fine per il nostro contingente difensivo, con le conseguenze devastanti che ne sarebbero potute derivare».
Giovanni Ghigonetto