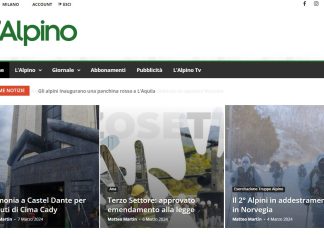Il generale Alberto Primicerj si trova ormai da tre anni a Bolzano, al vertice delle Truppe alpine. È tempo di porgli qualche domanda sulla sua esperienza di militare e di comandante. Ufficiale che si contraddistingue per la propensione alla concretezza, all’operatività, alla linearità dei rapporti, manifesta la sua vocazione alpina fin da giovane, senza incertezze, tanto che ai tempi dell’Accademia quando gli viene sottoposto un foglio per la scelta della specialità scrive nelle tre caselle di opzione: alpini, alpini, alpini. È facile quindi parlare della vita militare con franchezza. Ma sentiamolo.
Comandante, la scelta d’intraprendere la carriera militare è stata problematica o decisa?
Nessun tentennamento. Provengo da un ambiente alpino, mio padre è stato comandante della brigata Cadore, mio fratello è a Roma allo Stato Maggiore dell’Esercito. Ho avuto modo di valutare questa scelta senza condizionamenti, e per me è stato naturale pensare d’indossare la divisa.
Che ricordo conserva dell’esperienza dell’Accademia di Modena?
L’Accademia l’ho vissuta come un periodo di formazione molto duro. Il metodo educativo e i risultati che si ottengono sono sicuramente validi. Per un ragazzo degli anni Settanta, piuttosto movimentati, perdere privilegi e libertà della vita civile costa impegno e sofferenza. Ma la serietà dell’educazione forma e ti segna come uomo e come futuro ufficiale.
Qual è stato il periodo di comando che ricorda più volentieri?
Sono grato alle istituzioni e al Corpo degli Alpini che mi hanno consentito di fare delle esperienze interessantissime. A ognuno di noi che intraprende questa via piace comandare degli uomini, vivere in un determinato ambiente; si crede in certi valori che normalmente si esprimono stando a contatto con gli uomini. Ho però avuto modo di fare esperienze più vaste, di comandare reparti anche multinazionali al di fuori del territorio nazionale, di passare un periodo allo Stato Maggiore, di frequentare Scuole di Guerra anche all’estero, di sentire com’è l’ambiente diplomatico come addetto militare presso l’ambasciata d’Italia a Bonn. Ho avuto la grossa fortuna di passare attraverso tutte le tappe di comando: plotone, compagnia, battaglione, reggimento, brigata (Julia, n.d.r.), Divisione fino al comando di Corpo d’Armata presso le Truppe alpine. Quello che resta più nel cuore, che ti forma di più e che ti dà più soddisfazione e anche richiede un grande impegno è quello di comandante di compagnia perché sublima la figura dell’ufficiale degli alpini. È giovane, comanda i suoi uomini, ha autonomia decisionale che pochi in altre Armi hanno. E quindi si costruisce la quotidianità a contatto con l’uomo. Un’esperienza durata otto anni: allora era normale, ora un privilegio di pochi. Tutti premono, e giustamente, per fare questo periodo di comando. Credo che quel passaggio professionale mi abbia formato come ufficiale.
La provenienza geografica e la formazione eterogenea dei volontari sono una ricchezza o un problema?
Il fatto di avere giovani di diverse provenienze sociali e differenti livelli di scolarità è sicuramente una ricchezza. Si ha quasi un ventaglio completo di quella che è la società giovane del nostro paese. Si vedono certo le differenze che però unite in un unico reparto creano un valore aggiunto. Rispetto alla leva obbligatoria abbiamo meno laureati ma nessun analfabeta. La differenza di provenienza regionale, un tempo vedeva una prevalenza di reclutati nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale, ora il rapporto si è ribaltato. Diciamo che circa il 70% dei volontari è di provenienza centro meridionale, anche se negli ultimi anni i VFP1 stanno segnalando un’inversione di tendenza. In un primo momento dobbiamo riconoscere che qualche problema c’è stato, però con gli anni ci siamo resi conto che vale il modo di dire: “Alpini non si nasce, si diventa”. Anche se provengo da una famiglia di alpini mi sono convinto che sono i sentimenti, l’addestramento, il livello di efficienza, le esperienze comuni, la vita sulle montagne e le fatiche a creare lo spirito di Corpo. Del resto, anche in passato gran parte dei sottufficiali, una colonna portante dei nostri reparti, proveniva da zone non alpine.
Quanto tempo è necessario per arrivare a strutturare reparti compatti ed operativi?
Quando si parla di reparto compatto s’intende un’Unità cui si possono affidare dei compiti. I compiti sono cambiati rispetto al periodo della leva quando erano fondamentali la difesa della Patria, del territorio e la salvaguardia del vivere sociale. L’operare dell’alpino di oggi è un po’ diverso rispetto a quello del passato e quindi anche il tempo per formare un reparto compatto, in grado di operare secondo quanto gli viene chiesto, è diverso. Al tempo della leva ci si concentrava sulla difesa della patria, la tutela delle libere istituzioni e quindi il livello di addestramento richiesto, validissimo, era relativo a determinate cose che poi in pratica non sono mai state chieste. Quindi tendevamo a creare lo spirito di reparto, a irrobustire quella resistenza fisica e quelle motivazioni che avrebbero consentito di affrontare determinate situazioni qualora si fossero verificate. Per raggiungere questi obiettivi i 18, 15, 12 mesi ci consentivano di avere reparti veramente spendibili. Posso dire qualcosa di più: dopo mesi, con l’addestramento che gli facevamo fare abitualmente, li portavamo ad essere operativi. Sono convinto che qualora fosse stato richiesto, com’è successo in Mozambico, gli alpini di leva erano pronti a dare e a dimostrare efficienza anche se il periodo di addestramento era inferiore. Adesso ai nostri alpini viene richiesto effettivamente di immergersi in realtà che non voglio chiamare di guerra, ma sono realtà dove si cerca di ricostruire un tessuto sociale in una nazione lontana, di garantire una certa sicurezza in una realtà in cui la minaccia c’è ed è mortale. Si attuano determinate procedure d’impiego in un contesto dove lo stress e la resistenza psicofisica a determinate situazioni molto rischiose richiedono una preparazione maggiore. Senza dimenticare che oggi i nostri militari si trovano a interfacciarsi con colleghi di altre nazionalità e quindi necessitano di competenze linguistiche e mezzi tecnologicamente avanzati. Ad un reparto destinato all’Afghanistan occorrono almeno 12 mesi di esperienza addestrativa, di cui un periodo di cinque-sei mesi di preparazione specifica. I mezzi con forti componenti di tecnologia che aumentano la sicurezza e il controllo del campo di operazioni richiedono un periodo di addestramento più lungo rispetto al passato. Quindi non solo addestramento psicofisico ma anche tecnico e di conoscenza.
Perché ci sono reparti di artiglieria terrestre, per noi da montagna, o di altra specialità con cappello alpino che non sono alle dipendenze delle Truppe alpine?
Come comandante delle Truppe alpine non sono strafelice che ci sia una realtà del genere, anche se capisco le motivazioni. Abbiamo in questo momento 4 reparti, due logistici, uno in Alto Adige e uno in Piemonte, un reggimento di artiglieria alpina, il Vicenza a Trento, e il 2° Trasmissioni a Bolzano, che indossano la divisa completa degli alpini, svolgono anche attività in montagna nell’ambito della loro specialità e non dipendono dal comando delle Truppe alpine. Questo deriva dal fatto che con passate ristrutturazioni e specializzazioni alcuni reparti sono stati tolti al nostro comando e affidati a comandi più specialistici. Questi reggimenti si sono veramente battuti per conservare il cappello alpino in quanto si sentivano parte della famiglia alpina e noi li sentiamo sempre nostri figli.
Le missioni all’estero in questi ultimi anni hanno assorbito buona parte della vostra operatività: sono servite ad elevare la professionalità dei reparti?
Sicuramente sì. È stato un modo per mettere in pratica tutto quello che, anche nel periodo in cui avevamo la leva, abbiamo trasmesso come insegnamento e come capacità operativa ai nostri reparti. È un po’ come passare dalla Fortezza Bastiani (dove l’ufficiale Giovanni Drogo per tutta la vita comanda con rigore un reparto in attesa di un attacco dei Tartari che non arriva, n.d.r.), nella quale i soldati si preparavano meticolosamente in una lunghissima attesa dell’attacco che consentisse loro di mettere in pratica quello che avevano imparato, alla realtà vera, che è un po’ l’epilogo del romanzo, dove alla fine i Tartari o il nemico arrivano veramente. Noi siamo passati a questa fase successiva. Oggi i nostri ragazzi mettono in pratica quello che apprendono sul territorio nazionale nei lunghi mesi di addestramento e questo accresce la loro professionalità in quanto imparano a correggere gli errori, sanno cosa si deve migliorare, controllano di più le proprie reazioni e migliorano l’efficienza psicofisica. La capacità operativa e la professionalità crescono. Siamo al passo, anzi in certi casi migliori, di reparti di altri eserciti stranieri famosi.
Ci sono aspetti dell’organizzazione attuale dei reparti al suo comando che potrebbero migliorare se le risorse finanziarie fossero un po’ più generose di quelle attuali?
Se parliamo di risorse numeriche devo dire che in questo momento siamo non dico al cento per cento, ma siamo molto vicini a quanto previsto dagli organici. Non è la carenza di fondi che incide sulle percentuali della forza a disposizione. Invece se parliamo di risposte organizzative che possono derivare da mezzi, ma teriali o infrastrutture, che in questo momento soffrono, allora sì, la crisi finanziaria si sta facendo sentire se si vuole mantenere un certo livello di efficienza. Quando parlo di mezzi e materiali mi riferisco alle esperienze che stiamo facendo fuori dal territorio nazionale. Una maggior disponibilità di risorse ci permetterebbe di avere più in fretta e forse anche in quantità maggiore determinati equipaggiamenti, strumenti e anche mezzi idonei a garantire forme migliori di sicurezza o un controllo più efficace del campo di operazioni. Anche se devo dire che la Forza Armata in questo momento sta facendo degli sforzi enormi soprattutto per privilegiare la sicurezza del militare sul terreno e per non lasciar nulla d’intentato o di casuale. Siamo cambiati molto rispetto a quelli che erano gli alpini degli anni Novanta. Abbiamo purtroppo difficoltà a reperire risorse per fare al completo l’addestramento di specialità sugli sci, in palestra, le vecchie escursioni o arrampicate in parete che consideriamo essenziali sia per la preparazione dello spirito di Corpo che del fisico. Non mi riferisco ovviamente a quello operativo al di fuori del territorio nazionale dove i fondi ci sono e ci permettono di fare attività di preparazione.
C’è tanta soddisfazione tra gli alpini in congedo nel vedere ai vertici delle Forze Armate penne bianche e dietro a queste un bel gruppo di ufficiali con alto profilo professionale ed umano. È casuale o c’è una ragione?
Io credo che di casuale a questo mondo ci sia poco. Ci sono delle congiunture felici e il caso va sempre aiutato. Non certo nel senso che bisogna agire in maniera poco pulita o poco trasparente per addivenire a determinate situazioni come quella attuale per le Truppe alpine. Bisogna avere nello stesso momento delle persone che hanno veramente una capacità e una preparazione alle spalle tale da consentire di mettere gli uomini giusti al posto giusto. Ed è il momento attuale. Se ai livelli più alti della Difesa, della Forza Armata e di altre Unità multinazionali di vertice presenti in Italia ci sono in questo momento generali degli alpini o della vecchia artiglieria da montagna vuol dire che questo è avvenuto per capacità personale, perché nell’ambito dei loro corsi sono stati ai vertici o perché hanno avuto la fortuna di fare le loro esperienze da giovani, e anche da meno giovani, col cappello alpino, oltre ad incarichi di prestigio allo Stato Maggiore o all’estero. La formazione nelle Truppe alpine, averne acquisito lo spirito, i valori e la capacità psicofisica, è stato un grande vantaggio per arrivare al punto cui sono arrivati. Per noi alpini è una grossa soddisfazione.
Si sente dire che altri sacrifici saranno chiesti ai bilanci della Difesa: sarà la tecnologia ad avere la meglio?
Mi sono reso conto, per aver fatto un’esperienza personale di un anno in Afghanistan nel 2008 e aver comandato una brigata multinazionale in Kosovo nel 2004, che la tecnologia gioca e continuerà a giocare un ruolo crescente. Non c’è niente da fare. Non possiamo prescindere oggi dal fattore tecnologico e dal cercare di migliorarlo continuamente, anche perché l’avversario, per quanto i conflitti in cui ci troviamo immersi siano asimmetrici, sfrutta la tecnologia e la perfeziona. Non possiamo più prescinderne. Resto comunque dell’idea che la centralità dello sforzo debba riguardare l’uomo, perché il qualcosa in più che abbiamo e che tutti ci riconoscono è che continuiamo a curare, in modo vorrei dire ossessivo, la preparazione dell’individuo. È la parte centrale dei nostri sforzi. L’esperienza formativa dei nostri avi, vissuta in montagna, ci ha fatto capire come l’uomo, la sua capacità di resistenza di fronte alle difficoltà ambientali sono fondamentali per avere successo, sia come singolo che come piccolo nucleo.
Per chiudere con una battuta: militare è ancora bello?
Militare è bello. Alpino è bellissimo. Lo dico anche perché noi alpini in armi abbiamo la fortuna di avere un’organizzazione a fianco, anzi integrata con noi, l’Associazione Nazionale Alpini, che continua la sua opera di diffusione di valori, ma anche di aiuto materiale. Ci è stata molto vicina ultimamente per affrontare determinate situazioni. Quando si vedono certe immagini festose delle Adunate, feste di popolo, come potrà essere quella di Bolzano nel 2012, si capisce quanto militare fosse bello una volta e quanto continui ad esserlo oggi.
Vittorio Brunello