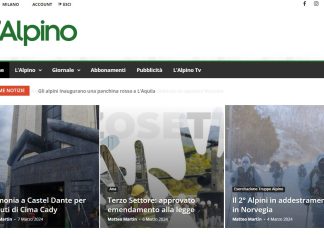Giacomo Ciotti da Sottocastello, 87 anni portati benissimo, è uno degli undicimila alpini che ha potuto fare ritorno dalla steppa o, se preferite, uno dei cinquantasettemila che partirono nel 1942 per la Campagna di Russia. A sentirlo raccontare di quel difficile periodo della propria giovinezza ti pare davvero di rivivere le esperienze raccontate da Giulio Bedeschi, nel suo Centomila gavette di ghiaccio o da Nuto Revelli ne La strada del davai .
Una tragedia oggi dimenticata, che allora coinvolse tanti giovani gettati in una guerra assurda, svaniti nel mare della steppa e dei quali, come qualcuno ha scritto, è rimasto solo il dolore delle mamme . Giacomo è il penultimo dei 5 figli di Rodolfo e Giovanna Tabacchi, nato il 13 ottobre 1922. La sua avventura militare iniziò il 15 novembre del 1941, quando ricevette la cartolina che lo chiamava ad Udine, alla divisione alpina Julia. Qui venne incorporato come radiotelegrafista nell’11º btg. misto del Genio, appena rientrato dal fronte greco albanese, e il 6 agosto 1942 la sua compagnia T.R.T. partì per la Russia, con radio campali e stazioni fototoniche ed ottiche.
La tradotta da Udine si avviò alla volta di Villaco, Monaco, Norimberga e Varsavia. Dopo Minsk il convoglio fu attaccato dai partigiani russi e mitragliato. Infine, dopo 15 giorni, giunse ad Isjum, da dove il viaggio proseguì, a piedi, verso il Don, distante 300 chilometri. La marcia fu funestata da un attacco di cavalieri ucraini, che ferirono il sergente maggiore Prati e uccisero il sottotenente Miege, ma alla fine si arrivò al Don, tra Novokamenke e Dukowoje, per prendere il posto di reparti ungheresi e tedeschi. Giacomo con il suo gruppo fu inviato a Saprina, dove si mise subito al lavoro per preparare le difese in riva al fiume, ma soprattutto i ricoveri sotterranei per resistere all’inverno russo, che era già alle porte.
Fu qui che Giacomo compì i suoi 20 anni. Nel dicembre ci fu il crollo della VI armata tedesca a Stalingrado ed i russi diedero il via all’offensiva sul Don, sfondando i settori rumeno ed ungherese, oltre a quello della 385ª divisione tedesca. L’11 dicembre la Julia fu inviata a chiudere la breccia e Giacomo con i suoi compagni fu aggregato al btg. L’Aquila e spostato a Seleni Jar, 300 chilometri più a sud, dove si dovevano fermare i sovietici che, oltrepassato il Don, cercavano di aggirare il nostro schieramento per chiuderlo in una sacca. Sebbene superiori in uomini e mezzi, i russi furono fermati per primi dagli alpini de L’Aquila che tra il 19 e il 25 dicembre persero 815 uomini.
Ai superstiti del battaglione si affiancò l’intera Julia, che mandò all’attacco perfino i genieri ed i conducenti, costretti a combattere con le baionette dopo che le armi automatiche erano state rese inservibili dal gelo. Fu in questi dolorosi frangenti che i tedeschi definirono la Julia Divisione miracolo ed il gen. Eibl chiamò gli alpini Panzersoldaten . Verso metà gennaio la Julia iniziò a ripiegare, ma era in ritardo: con eroici sacrifici cercò di unirsi alla Tridentina, ma fu quasi annientata dai russi, tanto che ben pochi si salvarono.
Giacomo iniziò così il suo calvario, con l’unico obiettivo di salvare la pelle: Gettai il fucile e le bombe a mano per non avere pesi inutili, il freddo era intenso, più di 40º sotto lo zero, mi avvolsi in sei coperte da campo, ai piedi misi un bel paio di scarponi e mi fasciai le mani con delle calze di lana avute da mia madre e così bardato iniziai ad avanzare nella steppa. Era una marcia estenuante, costellata dalle incursioni dei partigiani e più di una volta mi toccò di fuggire sotto i colpi dei loro parabellum . Alla sera cercavo ricovero nelle poche isbe, dove riposavamo tutti accatastati uno su l’altro, senza togliere mai le scarpe. Una notte mi addormentai in una di queste abitazioni, che erano fatte di paglia, e ad un certo punto qualcuno le diede fuoco, forse per riscaldarsi o forse per dispetto, perché non l’avevano lasciato entrare.
Dovetti fuggire e mi salvai per miracolo perdendo tutta la mia roba. Trovare cibo era un problema, in genere si entrava nelle isbe e si scendeva nelle cantine ma non si trovava niente. Una volta volevo entrare in una cantina e mi imbattei in un tedesco che voleva fare lo stesso. Lui tirò fuori la sua pistola, ma fui più svelto: lo presi a pugni e lo feci fuggire. Un’altra volta rubai da un’auto tedesca una gavetta di crauti, guai se mi avessero visto! Mi capitò anche un fatto curioso: in un villaggio capitai in un pollaio e riuscii a catturare una gallina, ma ero così stanco che la nascosi dietro la schiena e mi addormentai. Al risveglio la gallina era sparita, rubata da chissà chi. Dopo tante sofferenze e i tremendi scontri di Postojali, Limarew, Nikitowka e Arnautowo, arrivai con gli altri a Nikolajewka.
Ricordo benissimo quel giorno, il 26 gennaio, una giornata grigia e fredda ( 30º). La nostra colonna giunse alla mattina, ci trovavamo su una specie di altopiano e ai nostri piedi c’era la città con la ferrovia e il campanile. Su questo i russi avevano piazzato le mitragliatrici e ci tenevano inchiodati sul posto. Non si poteva avanzare e sapevamo che eravamo in trappola. Da lassù si vedevano i nostri della Tridentina che cercavano di rompere l’accerchiamento, ma senza riuscirci. C’era una intera formazione corazzata russa, schierata tra le colline e il paese, una situazione disperata e in più gli aerei russi ci sorvolavano, mitragliandoci. Io mi nascosi sotto la pancia di un mulo morto.
Combatterono per tutto il giorno e verso sera il gen. Reverberi salì su un carro tedesco, che era stato rifornito di benzina da un aliante, e guidò l’attacco verso il famoso cavalcavia della ferrovia, rompendo l’assedio e aprendoci la strada della salvezza Da Nikolajewka camminammo ancora per 200 chilometri e finalmente il 31 gennaio giungemmo a Shebekino, dove ci attendevano le prime ambulanze. Ci fecero la disinfestazione e ci mandarono all’ospedale di Dresda: qui mi diedero un chilo di zucchero e la Wehrmacht mi consegnò il nastrino della Campagna di Russia, che ancora conservo. In treno, finalmente giunsi all’ospedale di Cesenatico, dove arrivarono mio padre e mio zio: ero così magro che non mi riconobbero: avevo un principio di congelamento alle dita dei piedi e per il gelo mi era caduta tutta la pelle delle mani .
Ma intanto Giacomo era ritornato a baita e per definirlo più che fortunato basti un dato: per trasportare in Russia i nostri alpini ci vollero 200 treni, per riportarli a casa ne bastarono 17.
Walter Musizza Giovanni De Donà
Pubblicato sul numero di febbraio 2011 de L’Alpino.