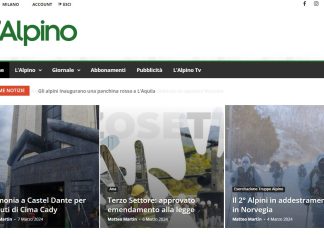La famiglia alpina è tutta da scoprire. Sotto il cappello con la penna nera siamo tutti uguali. Soldati e generali, alfabetizzati e laureati, contadini e professori universitari, operai e aristocratici. Tutti lo stesso credo, la stessa passione per la montagna, la bandiera, l’esperienza forte della naja. Un esempio emblematico ci viene da Diofebo Meli Lupi di Soragna, alpino e basta.
Discendente da una delle famiglie più blasonate della penisola, che gli attribuisce il titolo di principe del Sacro Romano Impero, non sente il peso di una storia che, dall’investitura feudale di Ugolotto Lupi da parte di Carlo IV di Boemia il 20 settembre 1347, arriva, attraverso una rete di parentele, alleanze, lotte, a coinvolgere il Gotha dell’aristocrazia italiana.
A tanta nobiltà non poteva mancare una dimora all’altezza, che Alessandra Mordacci così descrive nell’introduzione ad un bel volume sulla Rocca di Soragna, edito dalla Gazzetta di Parma: La fortezza feudale, poi villa di delizie e dimora dalle cento stanze, signora della Bassa’ s’innalza con la sua mole compatta e solenne. Ma attraversato il ponte sul fossato, dove vigilano acquattati due leoni di marmo bianco, il suo carattere severo muta inaspettatamente. Si apre allora allo sguardo un mondo di ambienti affrescati con gusto raffinato di una corte principesca .
All’ingresso principale del Castello, ad attendere una piccola delegazione di alpini, guidata dal capogruppo Corrado Azzali, dal caporedattore del periodico sezionale Parma Alpina, Guido Fascioli, dopo un cordialissimo saluto in sala consigliare del municipio da parte del commissario straordinario dr. Attilio Ubaldi, viceprefetto di Parma e della responsabile dell’ufficio cultura dr.ssa Daniela Fermi, c’è il principe Diofebo VI Meli Lupi di Soragna. Calca in testa con disinvoltura il suo cappello da sottotenente del battaglione Bassano, 6º Reggimento, 74ª compagnia, cap. Sandro Pelino, caserma Cantore, San Candido. Silenzio fuori ordinanza per il congedo, il 13 giugno 1965. Ci fa accomodare nel suo studio al pianoterra e con semplicità ma anche con calore, accarezzando due bei cani che gli fanno compagnia, risponde ad alcune domande per L’Alpino.
Come sei arrivato alla Scuola Militare Alpina? Nel modo più semplice. Dopo sei anni passati in collegio a Moncalieri, vita spartana, escursioni in montagna, freddo, caccia, condividendo la passione di mio padre, capitano degli alpini, combattente della seconda guerra mondiale e internato in Germania, alla domanda, nel corso del colloquio di selezione a Torino, dove preferivo fare il mio servizio militare risposi: negli alpini. E così fu.
Dura l’esperienza da AUC ad Aosta? Non più di tanto. Ero abbastanza allenato alla fatica, ad arrangiarmi, anche se debbo riconoscere che si lavorava senza risparmio. Durante una gara di orientamento topografico dovemmo attraversare la Dora con l’acqua che arrivava alla cintola. Non c’era alternativa. Ogni altra soluzione significava una perdita di tempo. Rischiammo, patimmo e arrivammo primi. Il capitano Manfredi, vedendoci in condizioni pietose, ci rivolse uno sguardo di compiacimento e di ammirazione. Due commilitoni che non se la sentirono di rischiare furono puniti. Non ricordo la motivazione, ma in quel campo non mancava la fantasia. Un sottotenente, cui mi permisi, da sergente, di dare del tu, mi consegnò scrivendo in bacheca: Dava del tu a io che ero lei .
Al reggimento, i rapporti con superiori e alpini com’erano? Beh, intanto non cominciamo a dimenticare i muli. Animali straordinari. La cavalleria alpina. Ottime bestie, guidate e curate dai conducenti in modo corretto riuscivano a portare basti, cannoni, vettovagliamento, anche su sentieri a rischio, ovunque. Che poi quei magnifici alpini che li accudivano fossero simpaticamente lavativi, è un altro discorso. Alla normale vita di caserma ci sono state delle parentesi per partecipare alle gare nazionali di sci delle Truppe alpine, esercitazioni, campi. Con i colleghi ufficiali e con i soldati c’era un rapporto molto bello, basato sull’educazione e il rispetto. Tra alpini c’è simpatia, affetto per il proprio simile, che più simile non c’è. Il mondo si divide in due categorie: gli alpini e gli altri. Dei primi puoi fidarti: sono di parola. Un biglietto di garanzia, o meglio, una pandemia che possiamo chiamare alpinite. Che ti porti addosso per sempre. Episodi?Tanti. Assegnato come sergente a Vipiteno, al corpo di guardia, facendo scattare energicamente i tacchi, mi presento all’ufficiale di picchetto, un sottotenente di complemento in area di congedo, e con voce forte e chiara mi nomino: Allievo Diofebo Meli Lupi . Mi squadra lentamente da capo a piedi con aria perplessa, un po’ schifata, poi risponde sillabando: E io sono , e giù un bestemmione.
Dell’esperienza del servizio militare ti resta solo nostalgia o anche qualcos’altro? Nostalgia, tanta. Alle lacrime, qualche volta. La generosità dell’alpino nasce dall’esperienza di trovarsi tutti nella stessa barca; così si crea un’unione indefinibile, che ti resta per tutta la vita. Ricordo tutti gli alpini della mia compagnia, uno per uno, i colleghi ufficiali, i luoghi della fatica. Ma parlare solo di nostalgia è riduttivo.
Perché il cappello alpino conserva ancora, anche nella società civile, una sorta di rispettosa sacralità?È un simbolo di unione; uguale per tutti. Rappresenta dedizione alla Patria, alla fatica, a quello che si deve fare, non a quello che conviene.
Chiusa la fabbrica degli alpini’, con la sospensione della leva obbligatoria, dobbiamo ritenere di essere arrivati al capolinea della nostra storia? La nostra è una storia che non si chiuderà mai: affonda le radici sulle gesta compiute, i sacrifici sopportati e il legame con i propri commilitoni. È come l’impronta lasciata dai dinosauri sulle rocce delle nostre montagne cento milioni di anni fa. Il senso del dovere per l’alpino e le alpine è una religione. Che si trasmette a chi ama misurarsi con le difficoltà della natura e lì si tempra. Non è una liturgia sopportare la fatica e i rischi della vita in alta quota. L’uomo non trova luogo migliore di quello per formare il suo carattere, stabilire il suo limite. Finché avremo soldati che si addestrano sugli stessi luoghi dove sono passati i nostri padri e dove anche noi abbiamo faticato, l’alpino sarà un punto di riferimento e la sua storia non finirà.
Tra alpini in congedo non esistono gerarchie. O meglio, si preferisce guardarsi in orizzontale piuttosto che in verticale. Perché? Per chi pratica la montagna le qualità dell’uomo che contano si evidenziano sul campo. Non è il caso di darsi arie: ce ne sono abbastanza in alta quota. Emerge solo chi ha doti fisiche e soprattutto umane tali da guadagnarsi la stima e l’affetto dei commilitoni. Il comandante costruisce il suo carisma con la dimostrazione di essere un uomo all’altezza del ruolo che gli compete. Non basta darsi importanza per arrivare un cima ad una vetta. Chi non ha i numeri viene subito ridimensionato.
Che ne pensi dell’impiego dei nostri militari nelle missioni all’estero? Li ammiro molto e li invidio. Avrei voluto essere al loro posto. Portano il nome dell’Italia in zone dove regnano la sopraffazione e la violenza. È un grandissimo onore contribuire a ristabilire la pace e la sicurezza in aree geografiche che rischiano di destabilizzare le fondamenta della convivenza civile.
e in Italia nell’ordine pubblico ed
in altre incombenze di competenza dei civili? Fatica sprecata. Ritengo non siano da utilizzare per compiti che possono essere svolti da altri. È meglio impiegarli in attività più elevate e non destinarli al ruolo di guardie popolari. Bisogna tenere lo sguardo sempre in alto, con fierezza, come l’aquila che ho visto qualche settimana fa scendendo da una pista del Cervino. Devono sentire il legame con la Patria e la dignità della professione. Mi piace associare lo spirito dei parà della Folgore al nostro.
Hai un sogno per il futuro dell’ANA? Certo. Che si continui ad essere primi nell’aiutare chi ha bisogno, come in Abruzzo, e che nel nostro comportamento ci sia sempre lo spirito di quando qualcuno stava per tirare l’ala e sentiva avvicinarsi una mano, magari altrettanto stanca, che sollevava il suo zaino. Il nostro passato è costruito su mattoni solidi, uomini di parola, credibili. È su questa strada che dobbiamo camminare.
Il piacevole incontro si chiude all’ingresso del castello, dove una volta c’era il ponte levatoio. Dopo una visita agli splendidi saloni, rimasti intatti negli affreschi, nell’arredamento, nell’atmosfera di seicento e più anni di storia passati per il grande portone centrale (si dice che anche il feldmaresciallo Kesselring vi abbia soggiornato nei primi mesi del ’45) resta forte il fascino delle memorie di una famiglia che vanta relazioni e parentele con i Grandi d’Italia e d’Europa. Segni qualificanti testimoniano ancora l’importanza della famiglia in parecchie città italiane, tra queste San Marino e Padova.
Nella città del Santo ci sono, con le insegne Meli Lupi, l’oratorio di San Giorgio, voluto dall’esule Raimondino, una via cittadina intitolata a Bonifacio Lupi e una prestigiosa cappella, all’interno della basilica, dove riposa dal 1390 il capitano di ventura Simone Lupi. Oggi a tenere vive le memorie degli avi c’è l’alpino Diofebo, principe di Soragna, persona semplice, affabile, appassionato di montagna e di storia familiare.
Ad ogni Adunata nazionale, non importa se ad Asiago o a Latina, inforca la sua moto ed è presente. Inutile cercarlo in prima fila nelle foto. Dimentico del nome che porta e dei prestigiosi incarichi che anche attualmente ricopre fra l’altro è presidente dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio e membro dell’Ordine di Malta è in mezzo agli alpini per rivivere le emozioni di un’esperienza senza eguali, o più semplicemente, alpina.
Vittorio Brunello
Pubblicato sul numero di marzo 2010 de L’Alpino.