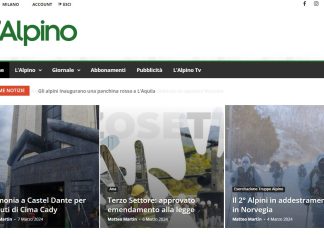Sono cresciuto in una piccolissima contrada della Lessinia veronese. Tre famiglie, quattordici bambini, dieci vacche in tutto. Prati e boschi ripidissimi. Belli da correrci per giocare, ma sfinenti quando si doveva portare a spalle l’erba per far mangiare gli animali durante l’inverno. Fu allora che decisi che a me di fare il contadino non sarebbe mai piaciuto. Eppure di quei tempi, che porto dentro con rimpianto e nostalgia, ricordo soprattutto i lunghi filò nelle stalle, mentre la neve ci imprigionava dentro notti senza stelle. Si era insieme, a parlar di nulla, se non a tessere la trama di un racconto, che aveva per tema la reciproca appartenenza e la felicità che si sperimentava nello stare insieme. Ricordo soprattutto le mani di mio padre che intrecciava cesti con i rami sottili presi dal bosco, dando loro forma e armonia. Sembrava che ci mettesse dentro la voce a quei cesti. Che erano piccoli se servivano per portare i dolci per Santa Lucia, più grandi se servivano per il raccolto nei campi.
Butto giù queste righe dopo aver letto il premiato e bellissimo romanzo di un giovanissimo scrittore, Paolo Cognetti, Le otto montagne. Un autore che mi piacerebbe portare per una volta tra noi alpini per dirci la sua su questo tema. Vi si racconta di un giovane cresciuto dai genitori con il culto per le cime più belle. Poi, a un certo punto, questo giovane, come un novello Pinocchio, se ne va lontano dalla famiglia, in cerca dei balocchi. È altrove il mondo che conta, quello che sembra sconfinato e dalle mille risorse. Non importa se è un mondo che ti chiude nella tua stanza senza più guardare fuori dalla finestra, mentre lo scenario si comprime su una tastiera.
Poi, però, al giovane del romanzo, accade che la morte improvvisa del padre, lo riporta sulle montagne conosciute da ragazzo, dove apprende di aver ereditato un rudere, incastonato lassù tra le rocce e le acque verdi delle nevi che si sciolgono. Ed è lì che scopre che, anche in sua assenza, la vita è continuata: «Immaginavo le sere, quando altri erano lì a parlare con mio padre, al posto mio… più che la gelosia, provavo il rimpianto di non esserci stato.
Mi sembrava di essermi perso le cose più importanti, mentre ero indaffarato in altre di così futili che nemmeno me le ricordavo». È la fotografia della vita, cari amici. Per far crescere relazioni vere, umane, bisogna esserci, stare insieme, passare tempo dentro una baita, parlarci, guardarci in faccia, litigare… Scrive un amico, Ivan Maffeis: «Ci riesce facile sentirci sempre altrove, indaffarati in altre cose, che poi, in momenti di verità, si rivelano per quello che sono, una sorta di distrazione personale e collettiva. La cultura digitale ha modificato in maniera significativa le nostre abitudini.
Ci si connette entro cinque minuti dalla sveglia. Durante la giornata controlliamo il cellulare di media ogni sei minuti. Una persona su due non lo stacca mai, neppure quando è in palestra o in chiesa. Sempre e comunque raggiungibili, siamo pure esposti alla possibilità di venire costantemente interrotti in quello che facciamo, di poter essere allontanati dagli altri per entrare in altre conversazioni». Siamo partiti dalla montagna, che per noi alpini è certamente luogo delle nostre origini e della nostra epopea.
L’estate ce ne ha regalato scorci pieni di mistero oltre che di memoria. Ma, scendendo a valle, forse ci è sfuggito il messaggio più importante. Ovvero che lassù si sta bene perché si sta insieme. Che lassù tacciono i rumori delle macchine e parlano quelli dei passi che avanzano. Che lassù tacciono gli strumenti digitali per lasciare il posto alla parola, quella dei suoni, degli sguardi e dei silenzi.
Bruno Fasani