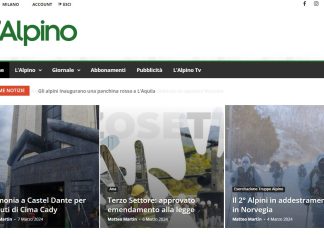Alle 22,39 del 9 ottobre 1963 un’enorme frana scivolò dal Monte Toc nel bacino artificiale del Vajont. Una tragedia che gli alpini ben conoscono e sulla quale molto si è scritto. Nell’intervistare uno dei primi soccorritori ho voluto concentrarmi sul “lato umano” della tragedia. Aveva 28 anni, Romano Bisignano, e comandava la 77ª compagnia del btg. Belluno. Concluderà, tanti anni dopo, la sua carriera come generale di Divisione, ma quell’esperienza di gioventù ha segnato la sua vita.
Come le giunsero le prime notizie del disastro? Quella sera ero rientrato tardi a casa da un’esercitazione. Ancora in mimetica, in piedi e con mia figlia in braccio, stavo guardando in tv una partita di calcio. Saltò improvvisamente la luce elettrica. Poco dopo, una telefonata: il comandante di battaglione voleva tutti gli ufficiali a rapporto: era successo qualcosa di grave a Longarone…
In caserma seppe notizie più circostanziate? Nulla di preciso. Temevamo che i terroristi altoatesini del Bas avessero fatto saltare la diga… Il comandante ordinò di prepararsi. Poco dopo l’intero battaglione partiva sui camion. Superato Ponte nelle Alpi, ci fermammo in attesa dei risultati di una prima ricognizione.
Come arrivaste sul posto e quali furono le prime impressioni? Alle tre di notte ricevemmo finalmente l’ordine di proseguire a piedi. Un procedere sempre più difficoltoso a causa dei detriti e delle carogne di animali che ostruivano la carreggiata. Dopo Fortogna la strada era impraticabile. Proseguimmo lungo i sovrastanti binari ferroviari e, superata una galleria e il ponte sul torrente, giungemmo alle porte del paese. Ci affidarono la frazione di Pirago, la prima che si incontra. Erano le 5 del mattino. A parte il nostro battaglione non c’era ancora quasi nessuno. Iniziammo a muoverci sul terreno, ma era buio fitto e le nostre lampade a petrolio non chiarivano certo la situazione. Faceva specie sentire sotto gli scarponi sabbia e terra bagnata.
Cosa vi si presentò agli occhi con il giungere dell’aurora? Pirago è sopraelevato rispetto a Longarone, proprio davanti alla diga. L’enorme ondata aveva percorso tutto il fondovalle ed era risalita fin oltre la nostra frazione. Poi, tornando a valle, si era portata con sé macerie e terra e aveva livellato tutto. Rimaneva in piedi solo il campanile della chiesa. Il terreno su cui ci eravamo mossi – adesso lo vedevamo – era costellato di cadaveri semisepolti nella sabbia. Fu una visione traumatizzante, da film dell’orrore. Del paese non rimaneva nulla: non case, non strade, non più la stazione ferroviaria: Longarone era diventato greto del Piave! Non c’erano feriti da soccorrere: a Pirago non trovammo nessuno vivo…
Per voi, questa visione deve aver comportato uno “tsunami emotivo”… Rimanemmo pietrificati: cadaveri nelle pose più innaturali, mutilati, alcuni cui la forza dell’acqua aveva tolto anche i vestiti… All’inizio ci fu un po’ di esitazione. Non eravamo emotivamente pronti e neppure equipaggiati per un evento simile: per dirne una, non avevamo guanti di lattice. Mi sfilai un guanto di pelle e lo diedi a un alpino: insieme estraemmo il primo cadavere. Poi i miei uomini non si fermarono più: lavorammo per 48 ore consecutive. Dapprima estraemmo tutti i cadaveri affioranti, a decine. Poi iniziammo a scavare. Rivedo gli atteggiamenti di sconforto ma anche di pietà dei miei soldati. Ricordo alcuni che piangevano mentre scavavano…
Per quest’operazione di soccorso i Reggimenti della brigata Cadore furono insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Civile. Ben presto, comunque, molti altri soccorritori si unirono a voi. Fu schierata tutta la brigata, arrivarono i Vigili del Fuoco e iniziò un’attività frenetica. La gestione dell’emergenza fu assunta dal comandante del 4º Corpo d’Armata Alpino. Il gen. Ciglieri, significativamente, trasferì la sua sede da Bolzano e piantò la tenda comando proprio al centro dell’area del disastro. Dopo due giorni ci concessero un po’ di riposo. Ora che non eravamo più soli, potemmo organizzare dei turni. Rimanemmo sul posto per 40 giorni. I sopravvissuti erano sconvolti. Per diversi giorni furono restii a rientrare nelle proprie case, per il timore di altre tragiche sorprese. Dopo i turni di lavoro, gli alpini venivano inviati a gruppetti negli abitati dove le case non erano state spazzate via, per dare una mano e tirar su un po’ il morale. Longarone era terra di emigranti. Quando si diffuse la notizia, molti tornarono. Ricordo il conforto che qualche mio soldato portava ad alcuni di loro che, increduli, vagavano in quella landa desolata cercando di identificare almeno il terreno su cui era stata la loro casa…
Oggi, dopo quasi sessant’anni, come rilegge quell’esperienza? Conservo tanti sentimenti e ricordi: il rinvenimento di quei corpi straziati, l’andirivieni degli alpini con le barelle, la commozione e la pietà con cui compivano quei gesti, le lunghe e fredde notti di scavo al chiarore delle fotoelettriche, l’odore di morte di cui erano intrise le macerie e la stessa sabbia e che rendeva l’aria irrespirabile… Furono giorni duri. Duri per l’orrore, per la fatica, per gli interrogativi che sorgevano. Ma eravamo consci che ogni nostro sacrificio era davvero poca cosa rispetto allo strazio della popolazione di Longarone. Mi emoziono ancora al ricordo di quelle giornate. Sono orgoglioso dei miei uomini, della dedizione e spirito di sacrificio che hanno mostrato. Con molti di loro sono tutt’ora in contatto: il Vajont ha cementato un legame tutto particolare, tutto “alpino”.
Marco Dalla Torre