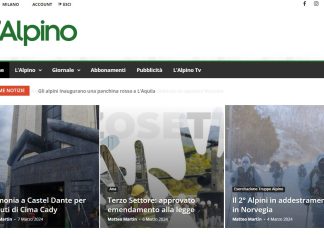Il trattamento dei prigionieri di guerra fu una delle questioni principali durante il primo conflitto mondiale. In teoria, i loro diritti dovevano essere garantiti dal trattato del 1907 e dalla Seconda Convenzione dell’Aja, un accordo entrato in vigore poco prima del 1914 e firmato da 44 Stati. Nella pratica però le cose andarono diversamente, le contingenze del momento non poterono garantire l’applicazione dell’accordo. Con il passare del tempo i prigionieri aumentavano e, contestualmente, le risorse diminuivano.
Per quanto riguarda gli italiani, è stato calcolato che i soldati catturati tra il 1915 e il 1918 furono circa 600mila. C’è da precisare che non tutti furono la conseguenza di catture vere e proprie. Alcuni, in realtà, si “lasciarono” catturare: una scelta disperata dettata dalla speranza di trovare, nei campi di prigionia, delle condizioni migliori rispetto a quelle in trincea. Ma, sicuramente, questi furono in numero limitato, inferiore a quello esibito da alcuni comandanti del tempo, poco adatti a condurre operazioni militari e quindi artefici di azioni avventate che causarono l’isolamento di interi reparti e la loro disgregazione.
A tal proposito, mi è giunto un plico inviato dalla signora Daniela Ziletti di Vestone (Brescia) con alcuni documenti del nonno Santo Monaci, classe 1889, nativo di Branzi (Bergamo), con una lettera dove le figlie lo ricordano “come una persona allegra e solare ma soprattutto generosa e molto buona” ed i nipoti, che purtroppo non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, affermano di avere raccolto testimonianze sul suo essere “un grande uomo”. Ma la cosa più importante, unica, è un piccolo blocco note a quadretti a forma di libretto (cm 16×10,50), come si usava una volta, scritto fittamente: si tratta del diario di prigionia del nonno. Dopo il servizio di leva nel 1909-1910, svolto tra gli alpini del Tirano per poi passare al 67º reggimento in seguito a “rassegna speciale”, nel novembre 1911 Santo è richiamato alle armi “quale complemento del Corpo d’Armata mobilitato per spedizione oltremare” in Libia (Guerra italo-turca 1911-1912); congedato, allo scoppio della Prima guerra mondiale venne di nuovo richiamato e inviato sul fronte del Pasubio, dove l’attuale confine amministrativo tra le provincie di Trento e di Vicenza ricalca esattamente il confine politico esistente fino al 1918 fra Italia e Austria-Ungheria. Su tale massiccio all’epoca erano impegnati circa 50mila soldati italiani.
Durante gli scontri avvenuti tra il 23 e il 28 marzo 1916 in località Sogli di Campiglia, Santo si distinse tanto da meritare una Medaglia d’Argento con la seguente motivazione: “Non curante del pericolo e animato da alto spirito militare recava ordini sotto l’intenso fuoco avversario. Durante un furioso assalto col suo contegno calmo ed energico, riusciva ad infondere ordine in un manipolo di compagni superstiti trattenendo e fugando il nemico superiore di forze”. Nella primavera del 1916 l’esercito austriaco sferrò una poderosa offensiva, chiamata Strafexpedition (spedizione punitiva), che ebbe il suo culmine nella battaglia del 2 luglio, dove gli italiani persero 2.797 uomini tra morti, feriti e dispersi; gli austriaci 587. L’arrivo di rinforzi permise di arrestare l’offensiva, tuttavia le truppe italiane si trovarono sul ciglio estremo del Pasubio.
I combattimenti seguenti, precisamente il giorno 10, costarono la cattura di Cesare Battisti e Fabio Filzi, impiccati dopo sommario processo il 12 luglio a Trento. Mentre, nello scontro principale del 2 luglio, fu fatto prigioniero il nostro Santo. Lasciamogli la parola con le sue memorie di prigionia: “Dopo un aspro combattimento sul Monte Pasubio per mancanza di forze e munizioni fui preso prigioniero, ed era il giorno 2 luglio del 1916 alle 2 pomeridiane. Appena fui preso mi disarmarono e mi frugarono per le tasche se avevo oggetti di importanza per la guerra (…) e poi mi presero e mi accompagnarono fino alla sua seconda linea (…) e lì trovai altri miei compagni presi poco prima, parecchi erano feriti”. I prigionieri furono caricati di “pesanti barelle dei feriti nostri e suoi (…) e camminammo fino alle 10 di sera con questi poveri feriti che si lamentavano senza una goccia d’acqua, una sete da dannati, proprio i feriti piangevano dalla sete e dal dolore poveretti (…)”. Anche Santo fu obbligato a trasportare quelli più gravi, seppur ferito ad una mano “però il dolore non era tanto forte e a forza di stenti arriviamo alle 10 di sera (…) dico la verità che ero più morto che vivo tra la fame e la sete e la stanchezza, il dispiacere che mi rodevano, ero proprio sfinito che avrei preferito morire”. (…) Appena arrivati posiamo i nostri feriti e poi ci portano sotto un abete e subito ci si fa intorno a noi gli austriaci e con segno di disprezzo dicevano: ‘Taliano, Taliano, morte a Taliano porco’ e fra me dicevo ‘povero me, dove sono mai capitato’ e piangevo come un bambino e dicevo al Signore perché non mi aveva fatto morire (…).
Finalmente vengono con un mestolo e una marmitta con del caffè e chi aveva la gavetta lo pigliava un sorso e gli altri che non avevano nulla non ne presero, e fra i quali ero uno anch’io che non avevo il recipiente e dovetti rassegnarmi a rimanere senza. Io ero ferito ad un dito e era tre giorni che ero ferito, la ferita era leggera ma non avendola medicata tutto sporco alla notte cominciò a gonfiarsi tutta la mano e il braccio, e alla mattina non ero più capace di muoverlo, allora glielo feci vedere che era impossibile che potessi portare una barella così pesante, e quel soldato (…) non vuole sapere niente e mi disse in dialetto suo forte: ‘Anche te la tua barella come gli altri e fila e ricordati che qui non sei in Italia, qui comandiamo noi e non Cadorna’.
Dopo qualche tempo una sosta che ha il sapore di normalità: “E poi ci fermano in un piccolo paesetto e ci conducono nel cortile di una casa (…), ci fanno sedere all’ombra di grossi alberi di gelso, e ci portano da bere il tè, cosa che non avevo mai bevuto, e con una sottile trancia di pane con sopra un po’ di marmellata, e me la mangiai contento, mentre stavo mangiando un capitano medico con una macchina fotografica si mette in posizione per fotografarci, allora non volli che la mia faccia fosse vista in pubblico e abbassai la testa e lui fece scattare la macchina e la mia faccia di certo non l’avrà vista perché abbassai la testa in maniera che non poté vedermela. Finalmente dopo due giorni di attesa passa un autocarro vuoto e ci salimmo (…) appena caricati si parte la strada era stretta e sassosa (…) pareva che lo facesse apposta, andava in cerca di tutti i sassi e buche, figuratevi quei poveri feriti che urli ogni scossa che prendevamo erano veramente strazianti a sentirli (…) quei poveri diavoli che erano feriti alla gambe, alla schiena e bracci rotti (…) arriviamo ad una stazione provvisoria ove ci hanno preso il nome e i connotati (…) due ore dopo arriva il treno e salimmo sopra e si parte, il vagone era delle bestie e senza luce, una sentinella ci accompagnava, e si doveva andare a Trento, e durante il viaggio questa sentinella ci fece vedere una pagnotta e diceva se la volevamo comperare, noi subito ci chiediamo il prezzo, e dice che vuole sette corone, cose da scappare via subito, una pagnotta che sarà stata poco di più di un chilo, minchia che prezzi e che vuoi quando si ha fame è inutile la fame ci fa fare di tutto e fra una decina di noi l’abbiamo comperata e divisa non ce n’era per nessuno, ma pazienza”.
A notte tarda raggiungono Trento ma proseguono: “Alla stazione Innsbruck vi erano già i soldati ad aspettarci per condurci in un baraccamento. Alle due del pomeriggio ci portano alla disinfezione e al bagno e dopo ben disinfettati noi e abiti, ci portano in una sala di medicazione, (…) finito la medicazione ci portano in una baracca provvisoria e alla sera alle nove (…) in un ospedale apposta per i prigionieri di guerra italiani, là c’erano già molti altri disgraziati feriti e ammalati, e un po’ per stanza ci mettono a posto, per il dormire ci si stava male perché letti non ce n’era, solo pagliericci per terra, ma ci si arrangiava alla meglio, però non fui capace di dormire in tutta la notte, cominciai a pensare ai miei poveri genitori in che stato d’animo saranno stati a non sapere la mia sorte (…) più che pensavo mi pareva di vederli a morire del dispiacere (…) Dico la verità che quella notte il cuore mi doleva proprio da scoppiare, cercavo di farmi coraggio ma non ero capace e ogni tanto dovevo scoppiare in un lungo pianto, e passai tutta la notte così”. Dopo giorni di patimenti per la ferita infetta, finalmente “alla mattina venne il medico e tornò a visitarmi e mi fece un piccolo taglio, e mi estrasse una piccola scheggia e mi medicò, e cominciai subito a migliorare e in quattro giorni guarii quasi completamente.
Alla mattina dopo il medico chiese se ce n’era qualcuno che era un po’ infermiere e che aveva pratica per assistere i feriti e io gli dissi subito che me ne intendevo bene e lui mi mise subito come infermiere (…) cominciai a fare servizio. Il medico mi disegnò una stanza che conteneva trentotto letti e erano pieni di feriti e ammalati, figuratevi che lavoro giorno e notte (…) ma lo facevo molto volentieri perché era un servizio che era a scopo di umanità per i nostri fratelli, ma bisognava avere anche un cuore duro a dover assistere a tutte quelle operazioni, ce n’era di quelli che pareva impossibile che potessero campare, il cui corpo era in una piaga sola, certo che molti morivano delle troppe ferite che avevano, chi doveva perdere una gamba chi un braccio chi tutti e due, i piedi era proprio un vero patibolo”. Ma Santo bramava tornare in Italia: “Il tempo passava lento, le giornate erano dure, io mi ero fatto un fedele amico e si confortava l’un l’altro, e si raccontava le nostre tribolazioni che si aveva passato al fronte, e quelle che si passava durante la giornata. (…)
Un giorno gli chiesi se indovinava ciò che volevo fare, e lui mi rispose di sì, io indovino, egli disse, indovino tu vuoi fuggire e io non mi sbaglio perché anch’io sono del tuo parere e ci penso giorno e notte (…) per questo, e se potessi fuggire e poter andare ancora in Italia quanto sarei fortunato mi disse”. Dopo il tentativo di fuga, scoperto, l’ufficiale austriaco “ci levò dalla carica di infermiere e ci mise nella stanza degli ammalati e due giorni dopo ci fece partire con i feriti che andavano al concentramento di Sigmundsherberg e arrivammo il giorno 29 agosto (…) Dico la verità che partii da Innsbruck piangendo (…) perché non sapevo che fine sarei andato a fare perché tutti ci dicevano che si avrebbe passati dei seri guai e dicevano che nel lager si soffriva molta fame e maltrattati”.
Con l’arrivo al campo di concentramento finiscono anche le pagine del piccolo blocco note, non si sa se Santo Monaci scrisse altre memorie, probabilmente no per le dure condizioni nel lager di Sigmundsherberg che dal 1916 fu campo di prigionia per soli soldati italiani; poteva contenere 40mila uomini, ma i detenuti furono sempre in numero superiore. Una clausola del trattato d’armistizio, firmato tra l’Italia e l’Austria il 3 novembre 1918, fissava nella data del 20 novembre l’inizio del rientro degli ex prigionieri, ma non fu così. L’Austria aprì subito tutti i cancelli dei campi di concentramento dispersi nel suo territorio. Perciò Santo, dopo un viaggio a piedi tra regioni sconvolte dalla guerra, giunse in Italia il 18 novembre 1918, ma tanti prigionieri non fecero ritorno.
A Sigmundsherberg, nel cimitero costruito dai prigionieri, riposavano 2.398 soldati italiani. Secondo la “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico”, dei circa 600mila prigionieri italiani, 100mila perirono nei campi di concentramento ed il numero è da considerarsi per difetto poiché dal computo sono esclusi i morti delle compagnie di lavoro, disseminate nell’Europa Centrale. Il dato più agghiacciante è che la stragrande maggioranza perì di edema per fame e di tubercolosi. La fame e gli stenti furono quindi alla base dell’ecatombe di migliaia di prigionieri italiani.
l.f.