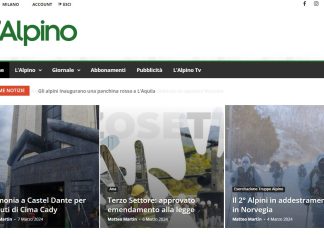A un secolo di distanza dal termine della Prima guerra mondiale non si sa ancora di preciso quanti siano stati i morti e i feriti tra i militari e i civili italiani. L’unico dato certo è costituito dalle 655.705 pensioni di guerra versate ai familiari dei Caduti. Un numero che, tuttavia, non considera due tipologie di morti per i quali la pensione non è stata erogata: gli esclusi per indegnità, vale a dire i fucilati e i morti condannati per reati vari, e i morti privi di parenti aventi titolo a ricevere la pensione di reversibilità” (Franco Carnevale, La Grande Guerra degli italiani, Milano 2014).
A questi vanno aggiunti i soldati deceduti successivamente per causa di ferite e malattie contratte durante la stessa guerra. Poco meno furono le vittime civili (circa 600mila). Una vera ecatombe di cui sono stati scritti tanti libri, ma pochi hanno narrato dei sacrifici e delle rinunce, delle ansie e dei dolori delle donne che hanno visto distrutte le loro famiglie. Mamme e spose di soldati partiti per il fronte che hanno avuta sconvolta la propria vita. Mentre gli uomini, indossata una divisa, uno status anche se non amato, avevano a supporto il dovere, la difesa della Patria, lo spirito di Corpo, lo stimolo della sfida con gli amici e contro gli avversari; le donne rimanevano praticamente sole nell’affrontare l’angoscia per i loro cari al fronte.
A loro non restava che pregare e sperare. Le poche lettere che giungevano non aiutavano certo; avevano solo da sperare che non fosse quella fatale, scritta da altri. “Cara Vittoria ti raccomando di tenermi in mente colla preghiera perché qui un minuto ci sei e un altro sei morto sotto le pallottole nemiche perché loro continuano a sparare (17 luglio 1915 – Angelo, Caduto in guerra)”. “Mamma cara, (…) il mio pensiero è sempre a te, che la tua benedizione mi accompagni sempre, ovunque, e ti sia di sommo piacere il saperti sempre amata dal tuo ultimo rampollo. (26 agosto 1915 – Emilio, Caduto in guerra)”.
“Cari genitori, (…) il giorno 9 restai ferito molto ma i dottori sperano la mia salvezza, se in caso dovessi perire sarebbe un gran dolore il dovere lasciare la mia bambina orfana dei suoi genitori (la mamma era morta subito dopo il parto). Cari genitori vi raccomando la mia bambina, se io non tornerò fate come sia vostra e datele tanti baci per me ogni giorno fino a che saprà dire: mio padre è perito in guerra … (Aristite, deceduto per le ferite il 19 settembre 1916)”. Lettere alle quali seguivano notti insonni, pianti soffocati, pensieri che avvelenavano quel po’ di riposo con scenari di morte che prendevano forma nel buio. Pensieri che erano ancora più angosciosi quando le lettere non arrivavano perché le normali comunicazioni postali erano interrotte dagli eventi bellici. Se poi i familiari al fronte erano tre o quattro o anche più, il tormento si moltiplicava.
La signora Silvia Musi di Guastalla (www.pietrigrandeguerra.com), che da anni dedica anima e cuore alla ricerca dei Caduti della Grande Guerra, ad oggi ha accertato che vi sono state: una famiglia con cinque Caduti (Sacchi di Cagli), ventisette con quattro e ben trecentocinquantasei con tre. Tra questi i fratelli Forcellini di Possagno, un piccolo paese ai piedi del Monte Grappa. Una famiglia quella dei Forcellini composta da tredici figli, degli otto in guerra, tre caduti in combattimento, uno superstite ma grande invalido: Giulio (caduto, Cima d’Asta 8 luglio 1915), Quirino, Umberto (grande invalido di Guerra), Federico (caduto sul Piave 18 giugno 1918), Guglielmo, Guido (caduto, Carso 8 settembre 1917), Augusto, Luigi (decorato di Medaglia Argento). Pensate all’ansia della signora Emma, la mamma in trepidazione per quegli otto figli al fronte.
La famiglia Forcellini era benestante, i figli erano tutti ufficiali, ed in tale contesto anche una mamma si sentiva orgogliosa di poter dare un così grande contributo alla causa nazionale, ma il suo amore materno avrebbe preferito tre figli tornati ad abbracciarla anziché tre eroi. Le grandi idee, giuste o sbagliate, sono quelle che spingono un individuo ed un popolo a dare tutto di sé, persino la vita. Così fu nella Grande Guerra, dove anche famiglie più umili si distinsero vivendo la guerra come un dovere, sia pure straziante. Una di queste è stata la famiglia Carrara di Aviatico, un piccolo paese posto su un altipiano delle Orobie ad oltre mille metri. Papà Angelo e mamma Maddalena avevano avuto tredici figli, sette femmine e sei maschi, di questi cinque furono al fronte.
Ci racconta Aurora Cantini, insegnante ed apprezzata scrittrice: «Era una classica famiglia contadina di montagna, risiedevano nella contrada Amora Bassa dove le abitazioni sono tutte attaccate, quasi a sorreggersi le une alle altre, con in mezzo la stradina che portava nei prati lungo il pendio. Erano abituati a lavorare dalle stelle alle stelle, coltivare campi e prati, accudire le mucche, tagliare legna nei boschi, salire all’alpe d’estate. Questo fin da ragazzi, mentre imparavano anche a leggere e scrivere». Finché giunse la chiamata alle armi di cinque fratelli: Fermo Antonio (cl. 1896, alpino, caduto sul Monte Rombon 2 agosto 1916), Vittorio Emanuele (cl. 1897, fante, caduto sul Monte Santo 14 maggio 1917), Giovanni (cl. 1886, alpino, caduto sull’Adamello 23 giugno 1918), Celestino (cl. 1883, sergente alpino, deceduto per cause di guerra nel 1932), Bernardino (cl. 1899, alpino, congedato nel 1920). Per mamma Maddalena, al dolore per la morte dei tre figli Caduti al fronte, si unì uno strazio ancora peggiore: i corpi non vennero mai ritrovati e non poté piangere su una tomba né porre un fiore o recitare una preghiera: nessun funerale per loro, nessun corteo, nessuna cerimonia ufficiale.
La madre – dopo aver accudito per anni il figlio Celestino, ferito nel corpo e alienato nella mente – si spense nel 1942 senza mai aver superato del tutto la tragedia dei figli. La difficoltà dei collegamenti, quindi la lentezza della posta, metteva in ansia i familiari. Alle volte passavano mesi prima di ricevere la notizia della morte secondo la prassi che prevedeva la comunicazione al sindaco del comune di residenza da parte del reparto o dell’ospedale: “Questo Comando compie il doloroso ufficio di partecipare alla S.V. Ill.ma la morte del soldato… Si prega di dare la triste notizia alla famiglia usando i dovuti riguardi”.
Il sindaco scriveva ai familiari secondo un succinto modulo standard: “Compio il doloroso incarico di parteciparle che il suo figliolo… è morto a seguito… Quest’Amministrazione… si mette a sua disposizione per qualunque bisogno e desiderio legittimo e santo nella tristissima contingenza. Si conforti al pensiero che la Patria segnerà il nome di … fra quelli dei migliori suoi Figli”. Famiglie distrutte, mamme, spose e sorelle che cercavano delle conferme, dei particolari, di riavere le poche cose lasciate dal figlio, dallo sposo, dal fratello: la foto con dedica, la medaglietta della Madonna che gli avevano donato, l’ultima lettera inviatagli. Dopo mesi arrivava la risposta: “il soldato è stato colpito da una granata di grosso calibro, rendendo così impossibile il recupero degli oggetti che detto militare aveva con sé”. Non restava che piangere e pregare. Le donne furono anche al fronte, come avvenne in Carnia.
La prima linea era in alta montagna e l’unico modo per fornirla di vettovaglie, munizioni, medicinai e attrezzi era “a spalla”, nel caso “a spalla di donna”, su per impervi sentieri. Gli uomini erano tutti impegnati al fronte, così le donne carniche non esitarono a raccogliere l’accorato invito del Genio Militare con le parole: «Andiamo, altrimenti quei poveretti muoiono anche di fame». Per questo fu costituito un Corpo di ausiliarie formato da donne di età compresa tra i 15 ed i 60 anni, che dall’agosto del 1915 all’ottobre 1917 rifornirono tutta la prima linea della zona, portando in quota tutto quando necessario ai soldati con capaci “gerli”. Tra queste rifulse la figura di Maria Plozner Mentil, “anima” delle Portatrici carniche, colpita a morte da un cecchino il 15 febbraio 1916. In quel periodo le donne furono anche protagoniste di una “rivoluzione sociale”. I posti di molti contadini e operai furono lasciati vuoti e le donne li occuparono.
Non che fossero del tutto nuove a questi lavori, ma il loro numero aumentò in modo esponenziale e furono presenti in settori del tutto nuovi come la metallurgia o la meccanica. Non essendo previste allora divisioni del lavoro, le donne erano obbligate a compiere gli stessi lavori dei colleghi maschi, anche quelli più pesanti. Non mancarono diffidenze ed atteggiamenti di rifiuto: “Nelle fabbriche meccaniche la presenza femminile era talvolta avvertita, specialmente dai vecchi operai, come un sovvertimento dell’ordine naturale e un attentato alla moralità” (Antonio Gibelli, “La Grande Guerra degli Italiani”, BUR, Milano, 2009). Un altro campo che le coinvolse fu l’assistenza, impegnate in iniziative a sostegno della guerra come le raccolte di denaro e materiali destinati alle famiglie dei soldati. In questo furono impegnate specialmente donne di estrazione borghese ed aristocratica, dotate di una buona disponibilità economica.
Le massaie “inventarono” degli indumenti antiparassitari per prevenire il problema dei pidocchi nelle trincee oppure promossero la raccolta dei noccioli di pesche ed albicocche che, opportunamente trattate, si trasformavano in sapone. A questo tipo di assistenza “materna” si affiancò anche quella in campo sanitario con la mobilitazione di volontarie della Croce Rossa e altre associazioni di soccorso. Secondo alcune stime, nel 1917 le volontarie della Croce Rossa furono circa diecimila e altrettante facenti parte di altre associazioni. A queste magnifiche donne, eroiche protagoniste della Grande Guerra, appartate e riservate, toccarono molte croci e scarsi onori, eppure le loro lacrime sapevano dello stesso amor patrio delle gocce di sangue versato dai loro valorosi uomini.
Luigi Furia