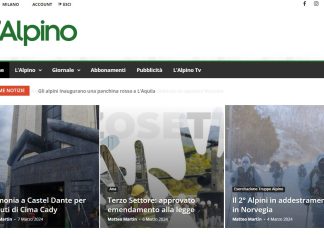Mi piace iniziare la lettura de L’Alpino aprendolo completamente sulla copertina e l’ultima pagina. Individui subito l’argomento dal titolo a destra e lo spirito alpino dalla foto di sinistra, sempre una montagna a tema. Novembre riportava il Bernina a sinistra e “Una mano al futuro dell’Afghanistan” in copertina. Quel bambino in ciabatte e vestito del suo shalwar mi ha toccato e spinto a raccontare un’esperienza che ho avuto la fortuna di vivere. Mi sono aggregato l’estate scorsa ad una spedizione che tentava la cima del K2.
Per me solo l’obiettivo di raggiungerne il campo base. Partenza il 7 giugno: volo Milano, Doha (Qatar), Islamabad (Pakistan). Qui, a 12 ore di volo, il mondo è un altro. I pochi alberghi “occidentali” sono dotati di check point all’ingresso, guardia armata, metal detector per accedere alla hall. Sulle strade della capitale, dritte ed ampie, continui posti di blocco con sacchi di sabbia e militari; poi un andirivieni confuso di vecchie auto, furgoncini carichi all’inverosimile di persone, motorini Honda con 2 o 3 persone a bordo, funzionari del traffico agli incroci senza semaforo, che fischiano in continuazione senza dare specifiche direttive.
Ottenuti i permessi per la scalata e pagato il dovuto, si parte sotto la guida di Alì, un giovane organizzatore di trekking e ascensioni agli ottomila del Karakorum. Lui, pakistano, orfano da piccolo, laureato, ha vissuto anche in Cina, Giappone, è stato negli USA e parla 4 lingue oltre all’urdu, lingua nazionale, e al baltì, lingua del nord, sua regione natale. Sotto le ruote del pulmino, la Karakorum Highway (KHH), l’autostrada, finisce subito.
Non per la velocità ma proprio perché non c’è più: inizia con tanto di casello e poi si dissolve tra lavori in corso, baracche, tende, gente che si sposta, animali che girovagano, villaggi che si materializzano dopo una curva e scompaiono alla successiva. Per arrivare a Skardu, 570 chilometri dalla capitale, ci vogliono due giorni su un’autostrada che spesso è a una carreggiata, con l’Indo a 300 metri di strapiombo e stravaganti camion decorati con vivacissimi colori che trasportano di tutto. Ogni tanto, “lavori in corso”: degli uomini male attrezzati rompono e rimuovono enormi massi caduti sulla strada. Se sono troppo grossi li aggiri… L’asfalto ormai è un ricordo…
Per guidare in Pakistan ci sono due sole regole, ci diceva il nostro capo spedizione: la prima suonare sempre, la seconda è che non ci sono regole. Lungo questa valle ripida, tortuosa e arida, con il turbinio violento di acqua sporca dell’Indo, appaiono ogni tanto modeste costruzioni di sassi, capre, bambini, “negozi”, uomini accovacciati, non vedi una donna. Il confine afgano è solo a 50 chilometri, di là ci sono anche i nostri alpini. Di notte i militari precedono il nostro furgone fino al successivo posto di controllo. Il giorno dopo giungiamo all’incrocio delle tre catene più alte della terra: Himalaya, Karakorum e Hindukush. Lasciamo la KHH, vecchia via della seta che qui prosegue per la Cina, e seguendo l’Indo sbuchiamo nella larga, ma non lussureggiante, piana di Skardu. Il Baltistan, regione di cui Skardu è il capoluogo, è nell’area del Kashmir, territorio da decenni in disputa tra India e Pakistan.
Se si osserva Google Maps, infatti, qui i confini sono tratteggiati, credo a causa dell’instabilità degli stessi e della contesa spesso armata in corso. Qui i tratti somatici delle persone cambiano: poche barbe, ricompaiono le donne, sempre con coloratissimi vestiti e pashmine. Si vedono donne nei campi, al pascolo con le capre e rare mucche, qualcuna anche alla guida di veicoli, altre con bambini… ma mai le vedi al mercato, se non accompagnate. La tensione della città è svanita, qui prevalgono pace e ospitalità. Dopo una breve pausa per approvvigionamenti tecnici, di viveri e acclimatamento sull’altopiano del Deosai a 4.000 metri, si parte per la valle dell’Hushe.
La jeep arranca su una strada stretta e polverosa, scorre lentamente il panorama di un modo di vivere che non mi è familiare. Acqua rapita ai torrenti che scendono dai ghiacciai, incanalata in modo primordiale ma sapiente su più terrazzamenti sassosi per far crescere orzo, frumento, patate, cipolle, albicocche e ciliegie. Donne con gerle di legna raccolta sui pendii dove le frane hanno ucciso le piante, bambini che si arrampicano sul verde degli alberi a strappare le foglie tenere per portarle alle capre, alberi circondati da spine alla base perché le capre non li mangino.
Bambine con fasci d’erba raccolta tra i sassi o estirpata in mezzo al cereale in crescita, in mano un falcetto dimensionato alla statura di chi lo usa. Ancora uomini senza mezzi, a riparare strade, frane, canalette, case e ricoveri, o con grosse accette a tagliar tronchi per ricavarne travi da costruzione trasportate su rimorchi trainati da qualche Massey Ferguson con copertoni da pista. Dopo 8 ore (150 chilometri) la jeep si ferma: la strada è proprio finita, la valle chiusa dal Masherbrum o K1, alto 7.821 metri. Ultimo villaggio: Hushe, 1.000 anime, a 3.200 metri di quota. Un nugolo di bambini, tutti vestiti poveramente uguali, circondano incuriositi e chiassosi questi strani visitatori, i primi che quest’anno arrivano in valle.
Nel nostro abbigliamento tecnico, mi vien da pensare credano sia carnevale. L’autista, baltì, cerca di allontanarli, ma il nugolo non si sfalda. Solo un sacchetto di caramelle al miele ottiene parzialmente l’effetto desiderato, e possiamo scaricare i nostri materiali. Siamo accolti con ospitalità, per loro siamo anche risorsa. Sono persone dallo sguardo profondo, attento, desideroso di uscire da un mondo vecchio. La mattina presto arrivano i portatori, e si caricano 25 chili a testa del nostro materiale. Sono un miscuglio di età indefinibile: scopriamo più avanti che vanno dai 16 ai 40 anni. Presto inizia anche la scuola: la giornata è regolata dal sole, che d’estate si alza presto.
Sono le 7 e piccole frotte di bambini, con ciabatte ai piedi o scalzi, riconsegnano i compiti del giorno prima svolti su una tavoletta di legno nero scritta con un gesso. Solo in questi anni lo Stato sta diffondendo l’istruzione primaria nei villaggi più remoti. In questa nazione, dal reddito annuo medio di 500 dollari, un maestro percepisce 1 dollaro al giorno, contro i quasi 10 di un portatore, anche se l’estate ai primi di agosto è già finita. Penso al nostro gruppo alpini di Farra, che sostiene bambini bosniaci a distanza e alla nostra Sezione che ha dato molto per una scuola sul Don.
Da qui non resta che camminare lungo la valle (ricordando il campo invernale sulle Alpi Giulie), poi la morena, poi i ghiacciai, per ammirare all’alba del quarto giorno dal passo del Gondogoro (5.650 metri), le cime più alte del pianeta: il K2 (Chogo Ri o Grande montagna, 8.611 metri), il Broad Peak, i 4 Gasherbrum, il Laila Peak, il Chogolisa, il Masherbrum, il Baltoro Golden Throne. Spettacolo infinitamente grande, con un pensiero al “Signore delle cime”. Foto di rito con un gagliardetto del Gruppo che anni fa Lino Lacedelli, primo sul K2 nel 1954, mi ha autografato. La sorpresa si fa grande: tra i portatori e le guide Lacedelli è una celebrità, eppure nessuno ha più di 40 anni. La fatica è tanta, la montagna unisce, l’amicizia cresce.
Dopo altri 4 giorni di cammino lascio i miei amici alpinisti al campo base del K2. Con Bruna, compagna di trekking e 4 portatori, ridiscendiamo lungo il Baltoro prima e il Braldu poi. Dopo altri 4 giorni siamo accolti ad Askole, che come Hushe è capolinea di un’altra valle. Un’altra nuvola di bimbi festanti e curiosi, circondati da persone che vedi per la prima volta ed è come se ti conoscessero. Ormai hai lo stesso odore addosso, di capra, latte rancido e kerosene del fornello da campo, ti offrono quel poco che non manca mai, il loro tè verde, chai, e il loro pane, il chapat”.
Abbiamo avuto fortuna meteorologica nel mese di giugno: da luglio in poi il tempo è peggiorato, i miei amici hanno dovuto rinunciare alla vetta, l’Indo è straripato, i ponti crollati, l’alluvione ha fatto 20 milioni di sfollati (su un paese di 180) e 1 milione e 600 mila morti. Al mondo solo pochi se ne sono accorti: è la colpa di essere poveri. Quando sono tornato in Italia, un amico mi ha consigliato di leggere il libro “Tre tazze di tè”, di Greg Mortenson, alpinista americano che si è perso sul ghiacciaio del Baltoro, trovato in fin di vita e salvato dalla gente del posto.
Lui, per riconoscenza, ha poi fatto costruire diverse scuole nei villaggi della valle. Per la mia breve esperienza, condivido quanto affermato nel racconto di Mortenson da Haji Ali (capo villaggio di Korphe) sulla gente che abita quei luoghi: “La prima volta che bevi un tè con noi sei uno straniero; la seconda un ospite onorato; la terza, sei parte della famiglia”.
Claudio Andreola
Gruppo alpini di Farra di Soligo