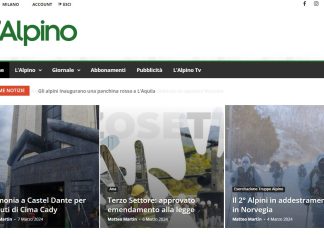Durante una delle mie solite escursioni estive, la punta del mio scarpone urtò qualcosa di metallico e di vivaci colori, affiorante dalla terra. Semicancellata la scritta ancora leggibile: “Antipasto Tripoli – Alici in salsa piccante – Forte Sultania” e un bel disegno di una nave da guerra italiana con tanto di cannoni e bandiera Tricolore sabauda al vento.
A casa, riguardando la scatoletta italiana, pensavo al percorso che aveva fatto prima di finire nella pancia dell’affamato artigliere alpino che se ne stava nella postazione col suo cannone sotto la Costabella. Tecnicamente si parla di logistica; vettovagliamento, per la precisione. Carne, pesce, frumento, zucchero, ecc. in arrivo sulle navi provenienti dall’America del sud e dall’Inghilterra scampate ai vari siluramenti dei sottomarini austro-tedeschi nel Mediterraneo, venivano invagonati su treni e mandati per la lavorazione ai rispettivi Magazzini Centrali Militari che ricevevano anche le merci del mercato interno nazionale.
Gli Stabilimenti di Casaralta (BO) e Scanzano Belfiore (PG) produssero circa 60 milioni di scatolette. Da questi magazzini, le derrate venivano trasportate sui treni ai Magazzini Territoriali e da là, tramite una complicata rete di distribuzione, finivano ai Depositi Reggimentali. Dalle varie posizioni del fronte scendevano le corveè con i muli o i carretti a far la “spesa” per ritirare gli alimenti da cucinare e distribuire ai reparti; oppure salivano i portatori o le portatrici come quelle della Carnia o del Cadore.
I panettieri stavano davanti ai forni mobili “Weiss”, di brevetto austriaco, che sembravano delle piccole locomotive: il forno era capace di sfornare 2000 pani nel giro di 24 ore che veniva poi biscottato. Ecco dunque la famosa “galletta”. C’erano anche le cucine vere e proprie, cioè delle baracche dove si costruivano dei forni in mattoni o pietre, si mettevano su i pentoloni e si seguivano le disposizioni per preparare il menù del giorno: combattente spettavano: pane grammi 600; caffè con 10 grammi di zucchero; formaggio grammi 40, riso grammi 120; carne grammi 200; legumi grammi 50.
Erano assicurate – in via teorica – circa 2.452 calorie a persona. Un po’ pochine, soprattutto per gente di vent’anni che spesso viveva a più di 2000 metri d’altitudine. Fu così che per sopperire alla scatoletta di carne “ufficiale” comparirono quelle delle Ditte private che omaggiavano i “Valorosi combattenti” con i cosiddetti “viveri di conforto” in confezioni patriottiche, del tipo che si pappò il nostro artigliere cent’anni fa. Oltre alle scatolette, il combattente aveva la gavetta che per gli alpini era di due litri, il doppio di quella della fanteria (ma il cibo all’interno era della stessa quantità). Certo che la gavetta doveva essere qualcosa di prezioso: ognuno se la lucidava ben bene (non tanto per igiene, ma proprio per non lasciar sprecato nemmeno un briciolino di cibo); poi c’erano i soldati “artisti” che prendevano un chiodo e bucherellavano il coperchio della gavetta per farne una grattuggia per la galletta o il formaggio. Il cucchiaio (non avevano in dotazione la forchetta e per coltello usavano la baionetta) aveva il manico ripiegato per inserire il coperchio della gavetta e farne un piattino.
Come bicchiere, il tazzino di latta con un segno sul bordo: era la misura della quantità di liquido di spettanza. Le borracce erano prima in legno (le famose Guglielminetti, fatte a Torino) che, essendo troppo fragili, vennero sostituite nel 1917 con quelle metalliche di forma rettangolare. E poi c’era il tascapane: la dispensa personale del soldato italiano! Ed era un po’ come le borse delle donne di oggi, meglio non guardarci dentro! Ma una cosa curiosa di certo non mancava: lo scaldarancio. Rotolini di carta di giornale arrotolati e imbevuti di paraffina. Una volta accesi, tre o quattro di questi servivano a riscaldare una gavetta, assicurando un cibo caldo anche sul ghiacciaio. L’invenzione era di antichissima origine giapponese e serviva per riscaldare l’acqua del tè. Portata da un giornalista in Francia durante la guerra del 1914, fu vista da una nobildonna italiana che elesse la sua cucina come prima sede del Comitato Nazionale per lo Scaldarancio.
Le amiche sue milanesi la imitarono, gli industriali regalarono delle attrezzature un po’ più professionali, la gente comune donò la carta, il motto del Comitato Nazionale Scaldarancio era: Riscalda Ristori Rincori. La popolazione nonostante soffrisse tremendamente la fame continuò nell’opera di sacrificio per non far mancare nulla ai giovani in armi; anche dopo Caporetto si mantennero i posti di Ristoro per i soldati di passaggio da e per il fronte; si servivano giorno e notte cibi caldi, bevande, ma anche cartoline, matite e altri piccoli oggetti atti a confortare fisicamente e moralmente le truppe. A fine guerra vennero spedite tonnellate di cibo alle popolazioni tirolesi, venete e friulane, grazie anche all’opera della Croce Rossa britannica e americana.
L’anno prossimo a Milano, in concomitanza con il centenario dell’entrata in guerra dell’Italia, si terrà l’Expo manifestazione internazionale per il cibo. A questo proposito, ho partecipato di recente a un summit dove sono state proposte idee innovative e forse un po’ bizzarre: un manager ha presentato la sua start-up (traduzione idea iniziale) che spera venga finanziata. L’ha chiamata streetfood (traduzione cibo da strada) mostrando i contenitori eco-trendy (traduzione ecologici e di moda) dove il cibo potrà essere venduto, consumato e riscaldato per strada, con un equilibrato menù vegano che oggi va per la maggiore.
D’improvviso si è materializzata nella mia mente l’immagine del buon artigliere in trincea, affamato. Tra le mani la scatoletta di “Antipasto Tripoli”, intento, sotto gli shrapnell, ad attingere dal suo gavettone un po’ di minestra con lo scaldarancio acceso, la tazzina e la borraccia: urlava contro il manager il suo menù da trench-food (traduzione cibo da trincea)… e chissà quali altri improperi!
Andrea Bianchi